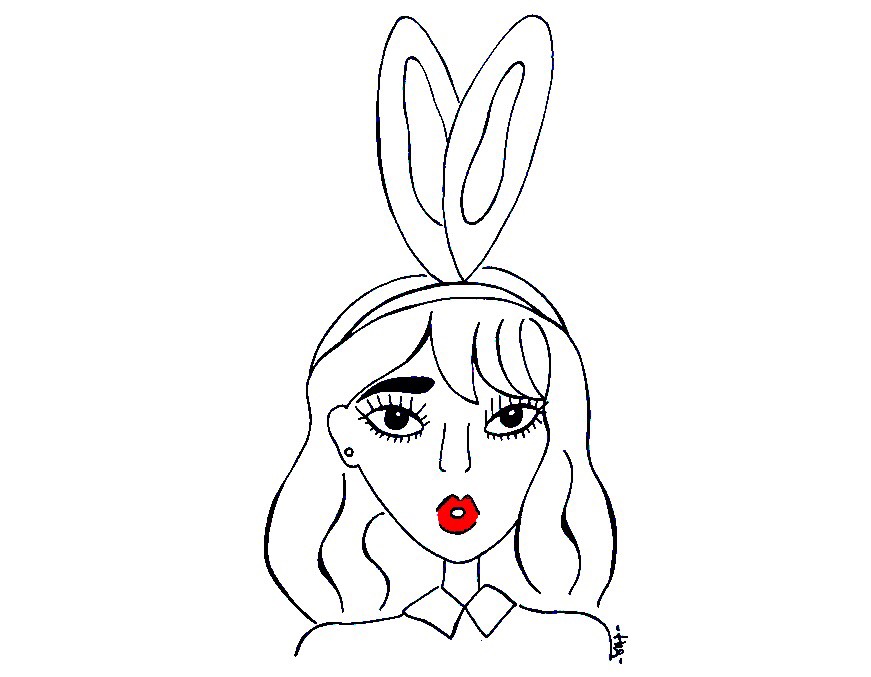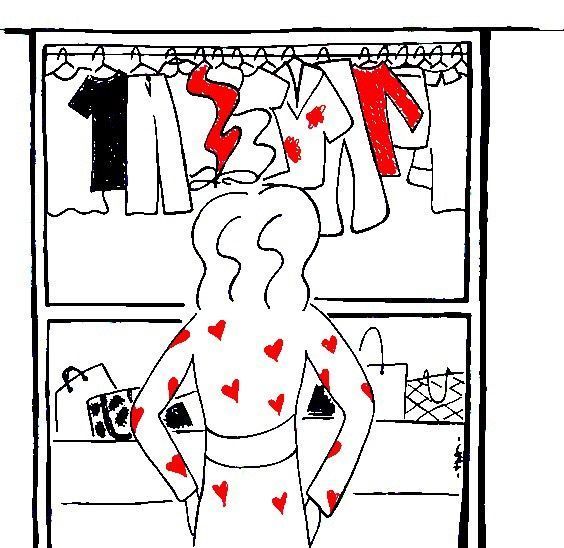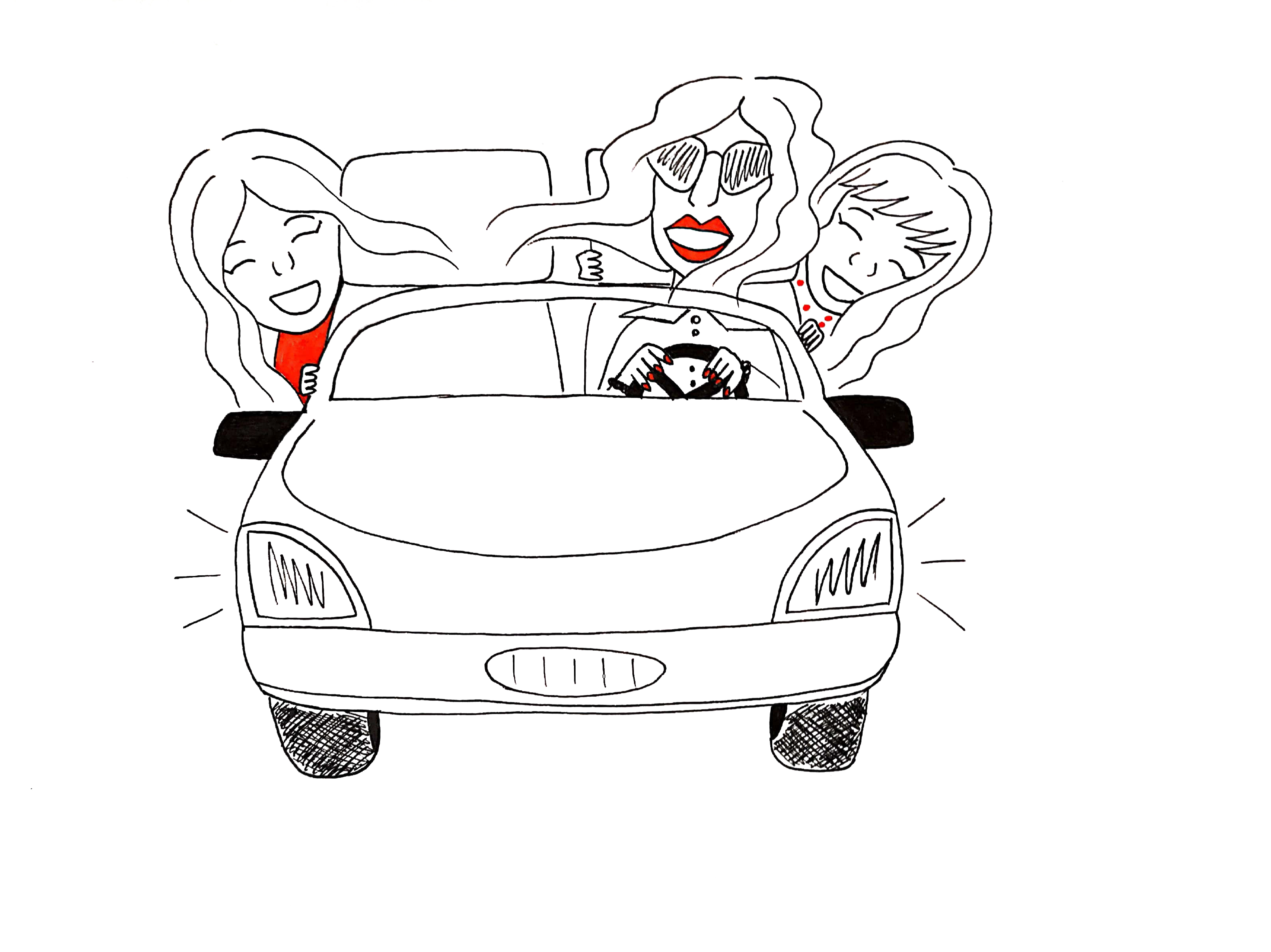crivo questo pezzo dal Giappone e a ispirarmi, inevitabilmente, sono le eroine dei cartoni animati con cui passavo i pomeriggi. Ho fatto merenda con i loro sogni, desiderando le stesse cose che loro desideravano, e se loro riuscivano a realizzarli, potevo riuscirci anch’io. Non mi spiegavo perché i grandi giudicassero diseducativa quella tv che mi faceva stare bene, ma la colpa — o il merito — del mio essere una sognatrice, credo sia proprio di quei personaggi televisivi che mi hanno trasmesso una dose massiccia di ottimismo e tenacia. Se per qualcuno è più allettante offrire solide realtà, io, invece, sono innamorata dei sogni e sono attratta dalle persone che ne possiedono uno.
Nei primi anni del blog, avevo intervistato tanti stilisti, anche importanti, ma erano gli emergenti a darmi qualcosa che gli altri non avevano: gli occhi della tigre, quelli di Rocky, tanto per intenderci. Domande, risposte: registrate con meno vocali e trascritte per farne articoli rispettabili. O forse più, per stare a contatto con quella passione, mescolata a dedizione e desiderio, di chi sente la necessità di far sentire la sua presenza nel mondo.
Ci fu uno stilista che mi aveva colpito in modo particolare, lo avevo intervistato a Parigi, nel salotto dell’albergo in cui soggiornavo. Avevo iniziato con una domanda di rito, chiedendogli come fosse nata la sua passione per la moda. Mi rispose che si sentiva un artista e che l’artista si esprime in forme diverse, con la pittura, con il disegno, con il ballo e anche con la moda: lui le aveva sperimentate tutte. Aveva frequentato il Conservatorio, si era laureato all’Accademia delle Belle Arti e dopo un passato come illustratore di libri per bambini, era passato a una piccola ma intensa esperienza nel mondo del ballo, finita per un infortunio. La moda arrivò solo più tardi, per esigenze di vita, iniziando a lavorare come venditore per uno showroom di Milano, poi per un brand importantissimo: Alexander McQueen.
La moda era un prezioso strumento di comunicazione, lo aveva capito in fretta, ma all’inizio, ciò che desiderava non era diventare a tutti i costi uno stilista o un designer, voleva e soltanto saperne di più, conoscere il metodo.
“Se il pittore conosce la tecnica per dipingere un quadro, io voglio conoscere quella che sta dietro la costruzione di un abito.”
Aveva lavorato a fianco di Sarah Burton per quasi due anni, ma non aveva intenzione di restare per sempre, aveva spedito il suo curriculum ad altre aziende, la prima a rispondere fu Moschino.
Si presentò all’appuntamento con il suo book di disegni, stavano cercando una persona capace di ritrarre facce di burattini per gli allestimenti delle vetrine: lui accettò. Cominciò da subito e lo staff diventò presto una nuova famiglia. Imparò alcune tecniche per lavorare tessuti e materiali e ogni volta che terminava qualcosa da esporre in vetrina, che fosse una grande zucca o un pomodoro gigante, se lo metteva in testa come un cappello. I collaboratori divertiti, che assistevano alla scena, lo spronavano dicendo: “perché non te li fai da solo i cappelli?”
Lo stesso Franco Moschino aveva frequentato l’Accademia delle Belle Arti con l’intenzione di diventare un pittore e per finanziare i suoi studi aveva lavorato come illustratore di moda, ma il suo interesse per l’arte si era trasferito dalla pittura alla sartoria. Rimasi colpita da quella curiosa coincidenza che li accomunava e gli chiesi perché, tra tanti accessori, avesse scelto proprio il cappello. Lui mi rispose che ne era sempre stato attratto. Nel tardo Ottocento, il cappello si indossava sempre e comunque, rappresentava una sorta di condizione che era andata svanendo negli anni ’60, con la rivoluzione femminile, che aveva eliminato questo ‘rigore’, ma era tornato in voga negli anni’80, dove i personaggi da cui traeva ispirazione, Steven Jones e Philip Treacy, ne avevano rivoluzionato l’idea, rendendolo un pezzo quasi indispensabile per completare un look.
La sua prima creazione fu una corona di gigli fatta di carta, poi, ne arrivarono altri. Decise di pubblicare le foto sui suoi canali social, era curioso di scoprire la reazione del pubblico, di fronte a qualcosa di tanto eclettico e come aveva previsto, la sua creatività non passò inosservata: a notarla fu una stylist di Vogue che chiese di averli per alcuni redazionali. Concluse la sua intervista, dicendomi che ringraziava quella buona dose di fortuna che si era messa sulla sua strada, indicandogli quella da seguire. E seppure fosse cosciente che la moda dovesse parlare a una grande fetta di pubblico, con un linguaggio semplice che tutti potevano comprendere, e che i suoi cappelli fossero riservati a un ‘bacino d’utenza’ ristretto, ogni volta che qualcuno indossava qualcosa di suo non passava inosservato. Aveva definito il cappello, e in particolare ciò che lui creava, come l’accento dell’abito, uno strumento per essere riconoscibili. In quell’occasione me me regalò uno: un cerchietto a cui era applicata la testa tridimensionale di una tigre, realizzata in velluto blu. Lo indossai a una festa, qualche mese più tardi, una festa organizzata da Dolce & Gabbana, a cui andai insieme a Matteo, il mio migliore amico. Eravamo al banco del bar in attesa dei nostri cocktail, lui continuava a toccarmi la spalla con insistenza, io non capivo perché. Mi voltai e mi trovai di fronte a una signora elegante e sorridente che indicava il mio cappello.
“I love your hat!”
Era entusiasta e mi stava dicendo che il mio cappello le piaceva, la ringraziai in modo cordiale, lei sorrise di nuovo e se ne andò.
“Enri: hai visto chi è?” mi chiese Matteo agitato.
“Una signora a cui piace il mio cappello.” risposi con nonchalance soddisfatta.
“No Enri, lei non è solo una signora, lei è un premio Oscar: lei è Helen Mirren.”
Rimasi di sasso. Dispiaciuta per non averla riconosciuta, felice di averle risposto con così tanta naturalezza e sempre più convinta che quello stilista aveva ragione: le sue creazioni non passavano inosservate. Quel designer si chiama Francesco Ballestrazzi, conosciuto grazie a un altro grande talento che conobbi in quegli anni: Caterina Gatta. Ma questa è un’altra storia di sogni e di chi non può vivere senza possederne uno.
Illustrazione: Valeria Terranova