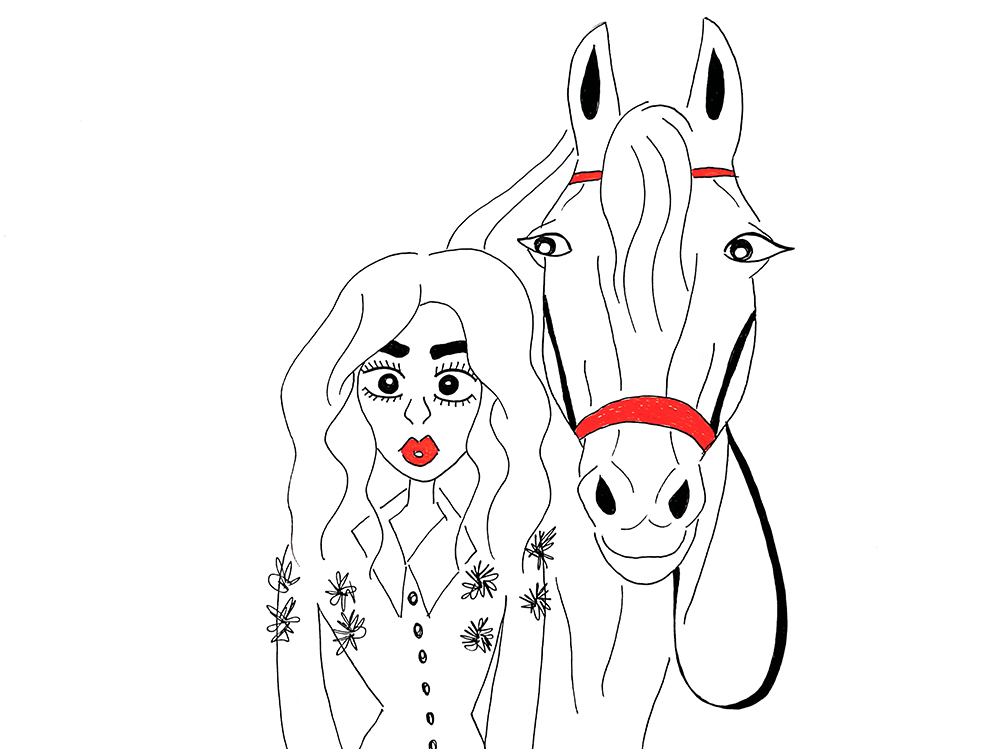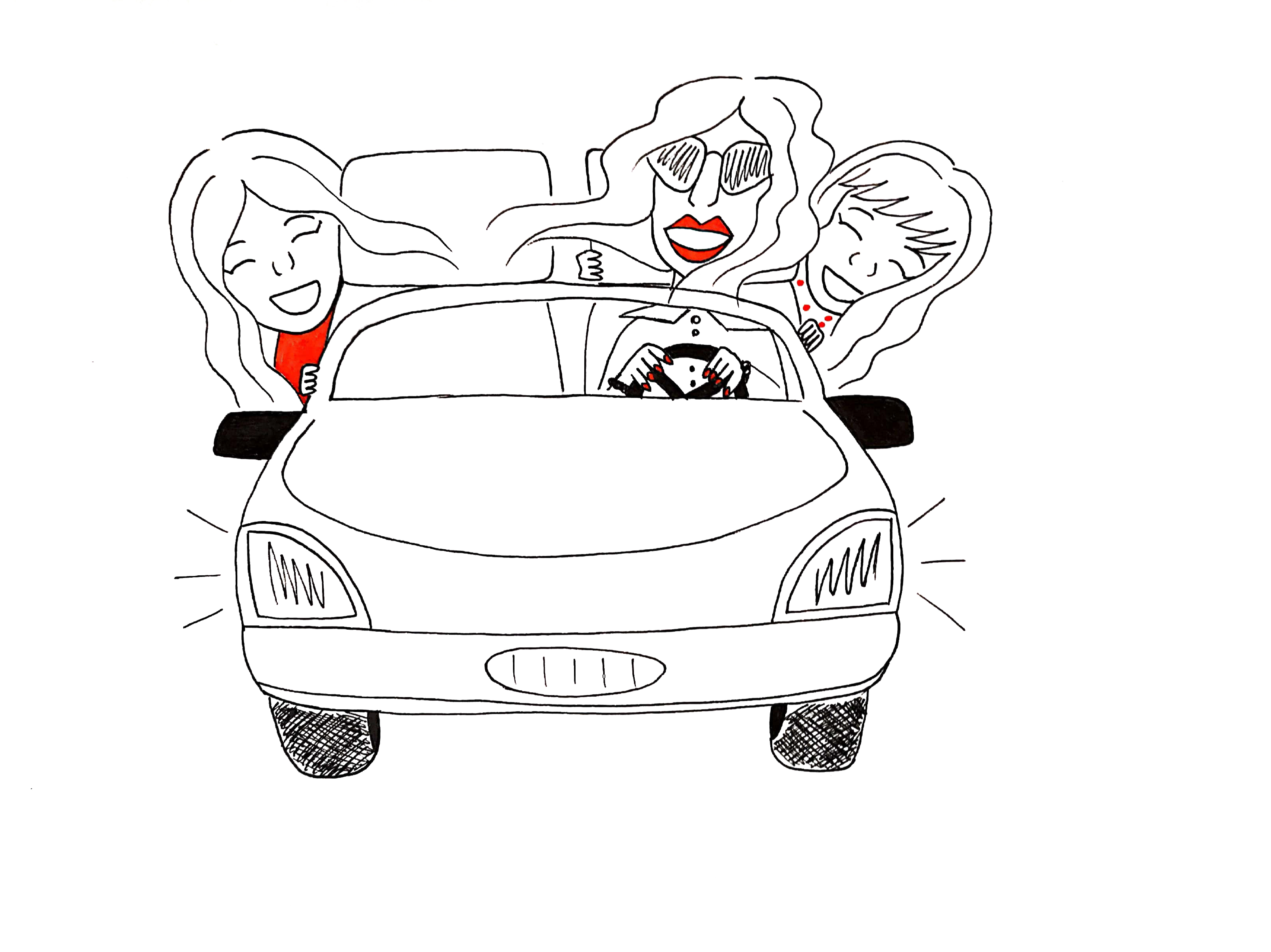poi ci fu la volta della bruttissima lite in Piazza di Spagna: quella, più che un film di spionaggio, sembrò una puntata di Suburra.
Generalmente io e Matteo andavamo d’accordo, ma quando ci capitava di litigare, le nostre discussioni accese si trasformavano in vere e proprie sceneggiate, e a Roma superammo noi stessi.
Ci trovavamo lì per un invito che avevamo ricevuto — stavolta in modo regolare — da un ufficio stampa di Milano. Uno stilista emergente, in voga in quel momento, stava per inaugurare il suo negozio monomarca nella capitale.
Io ci andai con un vestito blu interamente ricoperto di ruches. Di un altro stilista.
“Certo che potevi mettertelo uno dei suoi vestiti: stiamo andando al suo evento.” mi rimproverò Matteo sul taxi.
“E invece sarebbe stato banale”, obiettai. “Matte: nessuno va a una sfilata di Chanel con un total look Chanel.”
A ricordarmi che non ero al Grand Palais di Parigi, fu il ‘semo ‘rivati’ del tassista, che si era appena fermato all’angolo di Via del Corso. Matteo pagò e scendemmo dall’auto.
La mia teoria iniziò a vacillare una volta giunti davanti alla boutique. Alla vista dei numerosi invitati, mi sentii mancare.
Il designer in questione — che amavo moltissimo — aveva uno stile molto distintivo e assolutamente riconoscibile. E solo un non vedente non si sarebbe accorto che tutte le donne presenti indossavano un suo abito.
Tutte tranne me.
Mi feci coraggio, mi convinsi che non avevo nulla da temere. Sapevo che il mio giovane stilista avrebbe apprezzato l’outsider che c’era in me. Non era certo il mio abito a dimostrargli il mio affetto, ma la mia presenza. Lui era un cultore della bellezza femminile e quel vestito mi stava ‘na favola. Avrei anche potuto ispirarlo.
Mi ravvivai i capelli e presi Matteo sotto il braccio, in cerca della sua complicità.
Entrammo, e lo vidi in piedi di fronte noi.
Anche lui mi vide, sorrise e si avvicinò. Mi abbracciò, mi baciò, era felice di vedermi.
Il mio sesto non si era sbagliato: di fronte al suo volto compiaciuto, capii che la mia presenza gli aveva dimostrato il mio affetto, che non aveva bisogno di altro.
“Di chi è questo abito?” mi chiese sorridendo.
“È di Francesco Scognamiglio.” risposi con naturalezza.
Quelle furono le ultime parole che mi rivolse prima di andarsene e le sole per tutto il resto della serata.
“Io te lo avevo detto.” borbottò Matteo.
Mi rincuorava sapere che il tassista non fosse lo stesso del viaggio di andata. Farsi rimproverare continuamente era imbarazzante.
“Comunque non volevo snobbarlo, ho solo preferito assecondare il mio ego e il mio essere poco convenzionale. E poi questo vestito mi sta bene.”
Ero stata decisa, avevo detto ciò che pensavo e, soprattutto, non avevo rinnegato me stessa. Ma in cuor mio, sapevo che, dopo quella sera, avrei detestato quell’abito per sempre.
Nella mia mente il suo finale era già scritto: lavanderia, gruccia, cellophane. Poi nel mio armadio: etichettato come l’abito maledetto ricoperto di ruches. E mai più indossato. Peccato.
La mattina seguente, a consolarmi da ciò che nel mio immaginario era l’equivalente di The Day After Tomorrow, fu la mia grintosa mise.
Avevo messo in valigia LA giacca di Givenchy. Quella disegnata da Riccardo Tisci per Michael Jackson in tournée. Nera, in pelle, interamente ricoperta di borchie dorate.
Durante la notte era arrivato un forte temporale, ma ora, a parte le pozzanghere sparse per strada, c’era un bellissimo sole alto nel cielo: una luce perfetta. Chiesi a Matteo di accompagnarmi in Piazza di Spagna per fare delle foto.
Non ricordo cosa avesse provocato quella lite — a volte bastava un niente — ma le nostre grida erano riuscite ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine.
Un carabiniere si avvicinò a Matteo minaccioso chiedendomi se mi stava importunando. Per non farlo arrestare inventai che eravamo attori e che stavamo provando una scena del nostro spettacolo a teatro. Ci aveva creduto.
Quando rimasi sola con Matte, mi misi a ridere. “Siamo due cretini: solo a noi possono capitare queste cose.”
“Enri: mi stavano arrestando per colpa tua.”
“La colpa è di tutti e due, ma adesso basta: non pensiamoci più. Andiamo a fare le foto.” conclusi incoraggiante.
Detestavo mettermi in posa in presenza dei passanti, ma sapevo che con gli occhiali da sole il risultato sarebbe stato migliore e poi il riflesso delle borchie sulle pozzanghere creava un effetto pazzesco. Dovevo cogliere l’attimo.
E lì, nella nostra quite dopo la tempesta, dopo aver evitato il commissariato e dopo aver assunto una posa da scatto, sentii gridare alle mie spalle: “Signo’! Se sposti! Per cortesia se sposti che con quella giacca me sta a acceca’ er cavallo!”
Era il cocchiere delle carrozza che stava dietro di me, anche il signore vestito da centurione accanto lui mi faceva cenno di levarmi.
Se ci ripenso, ancora rido.
Illustrazione: Valeria Terranova