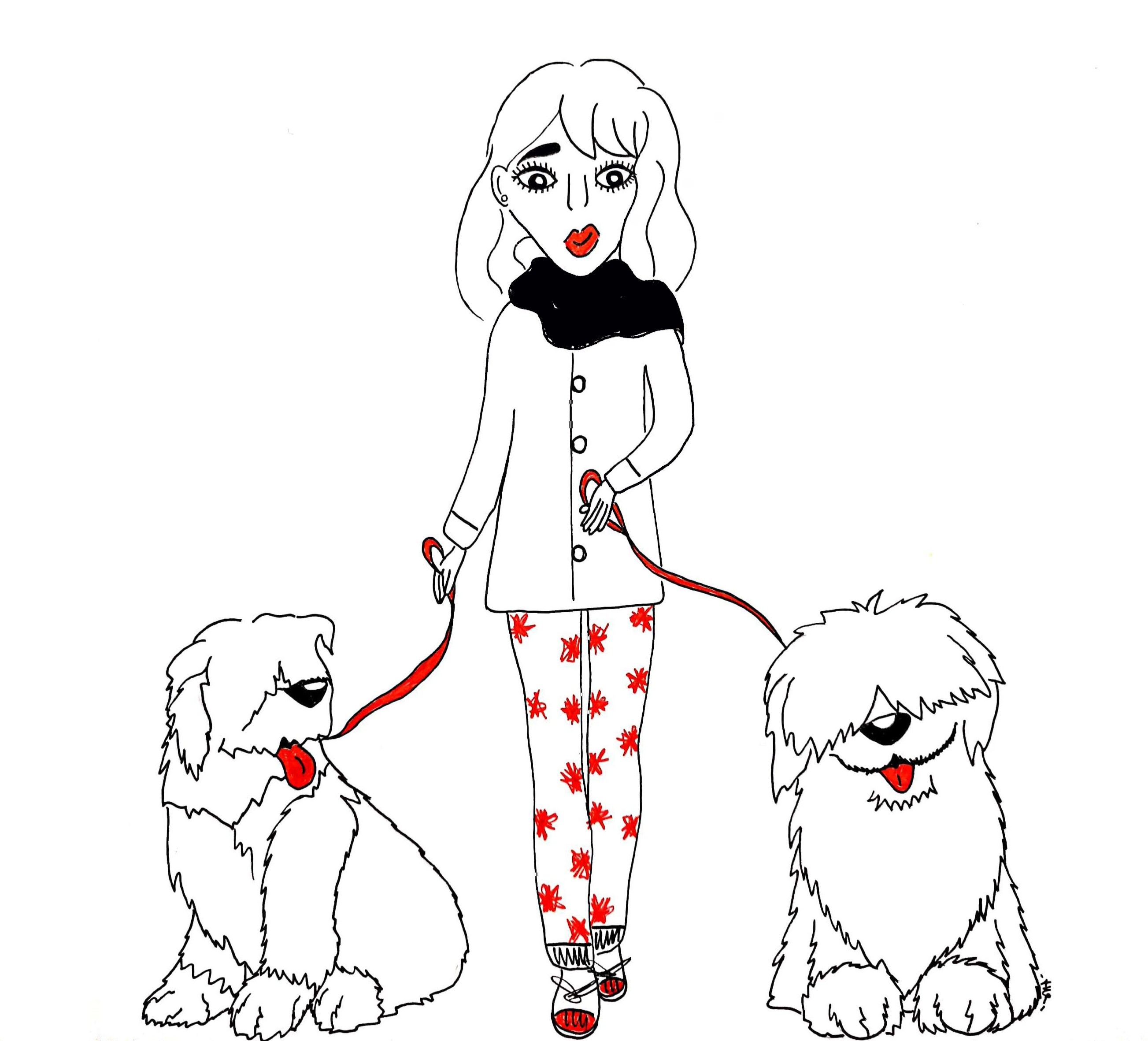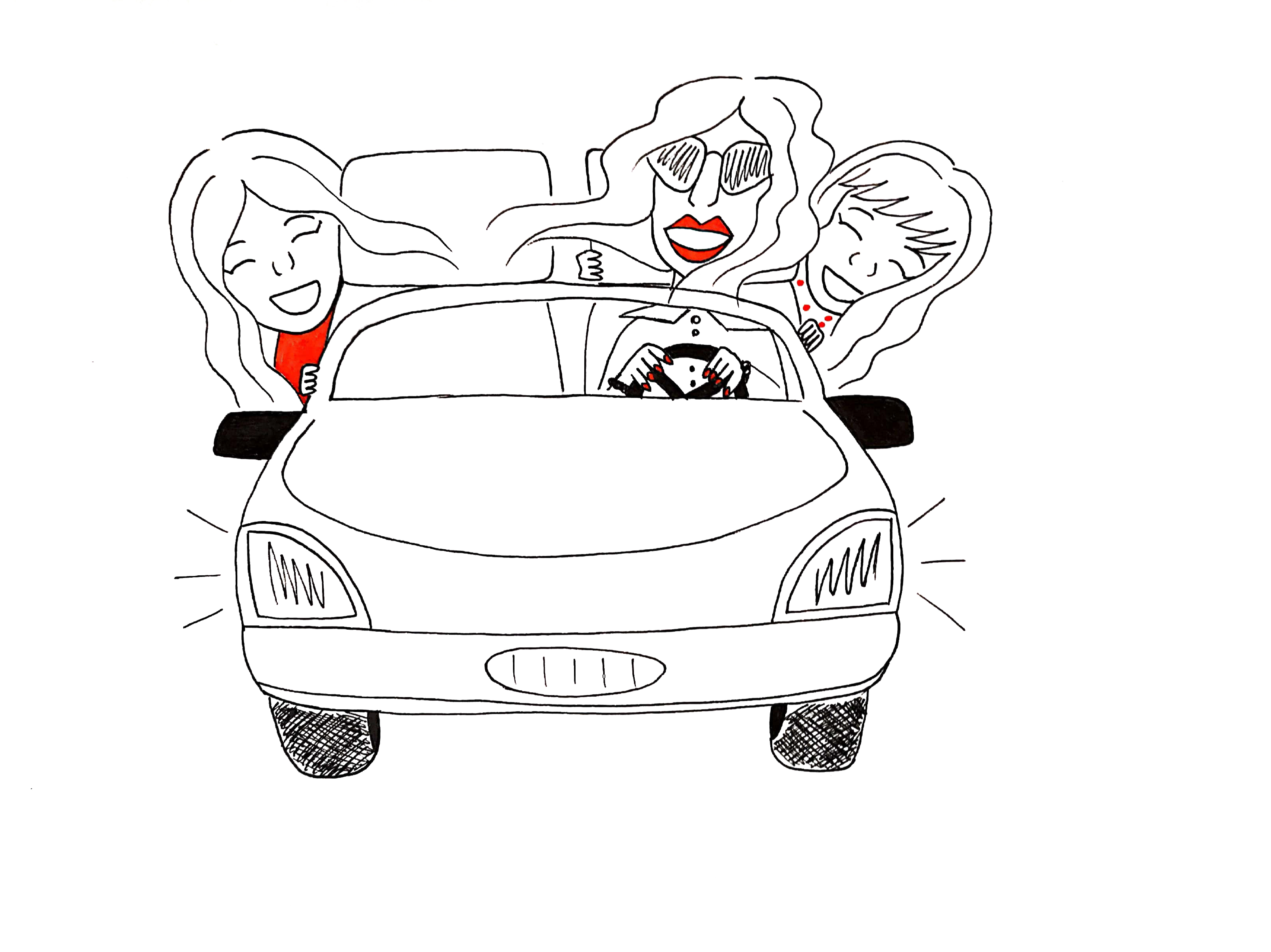evo reagire e farmene una ragione.
Ci saranno milioni di pantofole più belle di queste. La lucidità deve avermi abbandonato: sto per mettere al mondo una creatura e penso alle pantofole?
La droga non la voglio più. Farò questo figlio con le mie sole forze.
Anche in corridoio se necessario.
«Allora, dove eravamo rimasti?» mi sento dire come se avessi perso il filo del discorso.
L’ostetrica e la sua svizzera rimangono di sasso. «Be’, tanto per cominciare, potremmo fare due passi e raggiungere la sala parto…» suggerisce.
Nel suo sguardo, mi sembra di rivedere il terrore che divorava mio marito poco fa, quando la tappezzeria della sua auto era in pericolo. È evidente che sia difficile gestire luoghi e tempi di una donna che sta per partorire e una che è tentata di farlo dove capita va tenuta d’occhio.
Assecondo le sue volontà, decido di risparmiare il pavimento del corridoio, mettendomi in marcia per raggiungere la sala che ho di fronte.
Ci saranno un paio di metri, ma a me sembrano i quarantadue chilometri e centonovantacinque della maratona di New York. Qui non si tratta di tagliare un traguardo, ma un cordone ombelicale: la posta in gioco è molto più alta.
Giaco continua a sostenermi tenendomi un braccio intorno a quello che una volta era il punto vita, e a piccoli passettini riesco a raggiungere la sala parto. Ecco dove credevo di andare quando ho scritto lo stesso nome sull’etichetta della valigia.
Quando varco la soglia, scatta l’applauso.
I miei occhi faticano a nascondere l’irritazione causata dal loro battito di mani, ma è la frase che aggiunge l’ostetrica subito dopo a irritarmi di più:
«E adesso cominciamo a spingere, okay?».
Ancora con questo plurale. Va bene essere emotivamente vicini al paziente, ma questo è un po’ troppo da sbruffoni.
«Facciamo così: quando me lo dice lei, io spingo. Okay?»
«Okay.»
La stanza sembra persino più angusta della precedente. L’avrei tinteggiata in modo diverso, magari avrei aggiunto un tavolino circolare con qualche rivista di moda e un vaso di tuberose. Avrei appeso alle pareti un Roy Lichtenstein e un televisore satellitare a schermo piatto novanta pollici… Rimodernare una stanza? Ma come mi è venuto in mente?
Questa è uno spazio nato per vedere gente che soffre e alla gente che soffre non importa un bel niente dei giornali, dei fiori, di Lichtenstein e della televisione.
A stento mi adagio sul lettino con lo schienale inclinato, guardo fuori dalla finestra chiedendomi quando tutto sarà finito, e una nuova contrazione, decisamente più forte delle precedenti, mi fa capire che il momento che desidero non è poi così lontano.
Questa volta grido. Grido fino a farmi bruciare le corde vocali. Poi respiro, respiro forte. Giaco è vicino a me e cerca di tranquillizzarmi accarezzandomi i capelli.
«Amore, aiuto…»
«Enri, andrà tutto bene.»
L’ultima volta che lo ha detto eravamo in un maneggio in Sardegna e il cavallo su cui ero appena salita mi avrebbe disarcionato da lì a poco.
«Sta’ zitto! Zitto!»
«Ho detto solo che andrà…»
«Andrà di m***a se non stai zitto!»
Lui si ammutolisce e io mi sento in colpa.
Devo approfittare degli intervalli in cui cessa il dolore per spiegargli cosa succede, non credo che se ne renda conto: «Giaco, hai presente quando una donna ha il ciclo ed è nervosa? Ecco, calcola che quando una donna sta per partorire è nervosa all’ennesima potenza. Da qui: regolati». Gli dico accarezzandogli il viso.
«Oh mio Dio! Aiuto, oddio, aiuto, oddiooooo!»
Questa era una scossa sismica pari all’ottavo grado della scala Richter.
«Spingi Enrica, spingi!» mi incita l’ostetrica di Losanna. Non lo vedi che sto spingendo, brutta testa di ca**o? «Sto spingendo! Non lo vede?»
«Respira, respira…» mi sussurra dolcemente.
Okay: questo è più semplice.
«Ora Enrica ascoltami: quando sentirai arrivare la contrazione, comincia a spingere. Lasciati andare.»
In che senso? Posso farmela sotto?
«Okay… eccola… aiuto, aiuto, aiuto!»
«Spingi! Respira, spingi, respira, spingi, respira…»
«Insomma! Cosa devo fare? Spingere o respirare?»
Come se in una situazione del genere fosse possibile coordinare i movimenti.La decisione è solo mia: per non sbagliarmi, spingerò
sempre.
«Ahhhhhhhh…»
«Adesso spingi, spingi forte!»
Chiudo gli occhi, non voglio vedere, non voglio sentire, voglio solo farla finita, ma quando sento Giaco che mi prende la mano, so che ha ragione: tutto andrà bene.
«Amore, ci sei quasi» mi sussurra all’orecchio. «Amore, ci sono!»
Le cose che ci siamo detti quando abbiamo concepito Emma sono le stesse che abbiamo pronunciato quando è nata.
Emma pesa tre chili e cinquantatré.
L’ostetrica me la porge: è bellissima. Ha un ciuffo di capelli sparato all’insù e una tutina bianca con un tribale di cavallini.
«Enrica, ora devi provare ad allattare» sussurra.
Allattare. Dunque, vediamo… Ricordo di aver mancato uno degli appuntamenti al corso preparto, ma l’ho fatto per una buona causa: un private sale di Sergio Rossi. È proprio vero che un paio di scarpe può cambiarti la vita: mi sono persa la lezione sull’allattamento e adesso non so come fare.
L’ostetrica e il suo hamburger fanno per porgermi la mia bambina e il panico mi assale. «Io non mi ricordo niente» le dico stringendo Emma tra le braccia. «Anzi, non so proprio da dove cominciare.»
«Non sapere nulla sull’allattamento è meglio che aver ricevuto qualche cattiva informazione che può creare falsi pregiudizi» mi tranquillizza l’ostetrica. «Tutte le mamme possono allattare, la presenza del latte non è una casualità. Devi partire con il piede giusto, senza mettere in discussione la tua capacità di riuscirci» continua lei, mentre mi fa segno di slacciarmi la camicia da notte.
«Fidati del tuo corpo.»
«Cominciamo adesso?» le chiedo dubbiosa.
«Certo. Attaccare il bambino al seno entro due ore dalla nascita è ideale, perché il suo istinto di suzione è altissimo.»
Il suo istinto di seduzione? Oddio, mi sono persa un pezzo.
«Il suo istinto di…?»
«Di suzione» precisa lei in tono annoiato, come se avesse di fronte un caso disperato. «Più il neonato si attacca, più stimolerà la produzione di latte e ora tocca a te: offrile il seno.»
E non poteva dirlo subito?
Emma apre la boccuccia e inizia a tirare come se avesse trovato una cannuccia.
«Ahia! Fa male!»
«Insegnale ad aprire meglio la bocca, deve imparare a poppare e le labbra devono essere rivolte verso l’esterno, in questo modo…»
La svizzera prende in mano la situazione e pure la mia tetta, sposta le labbra di Emma fino a portarle nella posizione corretta e il dolore scompare.
«Fantastico! Sento che stiamo andando bene!» esclamo soddisfatta.
Poi mi viene un dubbio.
«E quando sarò da sola? Come capirò che ha fame?»
«È la tua prima volta e non sarà facile, ma ci sono alcuni segnali.»
«Per esempio?»
«Apre e chiude le labbra, volta la testa come se stesse cercando qualcosa. Porta le manine alla bocca e sospira.»
Mi devo ricordare cinque cose. Solo cinque. Posso farcela.
«Ma riuscirai a coglierli solo se terrai Emma vicino a te giorno e notte.»
«Giorno e notte?»
«Enrica, l’allattamento non ha orari. Nei primi tempi lo farai anche dodici volte nell’arco delle ventiquattro ore.»
Perché lei è così serena e io sono letteralmente terrorizzata? È come per la faccenda delle spinte: devo fare tutto io.
Non è stato facile, ma alla fine ho imparato. Ho imparato che allattare è una delle cose più belle del mondo. E anche se ho giurato che non porterò mai Emma in gita in Svizzera, a insegnarmelo è stata proprio quell’ostetrica con un hamburger grigliato sulla faccia.
Siamo a casa da tre giorni. Tobia ci stava aspettando… e anche quel maledetto ciuffo di peli che ho risparmiato prima di correre in ospedale. La casa è un disastro. E a parte il caos generale che non mi spiego da dove sia uscito, dopo essere diventata mamma, non posso fare a meno di chiedermi alcune cose.
Perché ogni mattina mio marito fugge di casa per andare al lavoro, come se l’ufficio fosse improvvisamente diventato l’unica priorità?
Perché i regali sono tutti per Emma e per me non c’è niente?
Ora, non voglio sembrare la mamma di Leonard di Big Bang Theory, ma per metterla al mondo ci ho messo nove mesi, undici chili, la nausea, gli sbalzi ormonali, le vene varicose, la fragilità capillare. E ho perso – seppur temporaneamente – alcuni pezzi cult del mio guardaroba, quindi perché nessuno ha pensato a me? Anche il più sfi**to degli atleti riceve una medaglia alla fine di una gara. Ma ti pare che dopo un’impresa eroica come il parto può bastarmi un mazzo di fiori di campo?
Perché tutti i parenti, e quando dico tutti intendo anche quelli dell’Argentina che non ho mai visto in vita mia, vogliono venire a casa a trovarci? Mi pento di aver scartato l’ipotesi della fotografia.
Se il giorno che ho partorito avessi mandato una foto a tutti con scritto «Emma è nata oggi, stiamo bene, ci vediamo per la cresima!» ora non starei cercando di cambiare identità, numero di telefono e di iscrivermi a un programma protezione testimoni per farmi assegnare un posto segreto in cui nascondermi.
Ma la sola domanda capace di togliermi il sonno è: perché i bambini non dormono tutta la notte?
Estratto dal libro