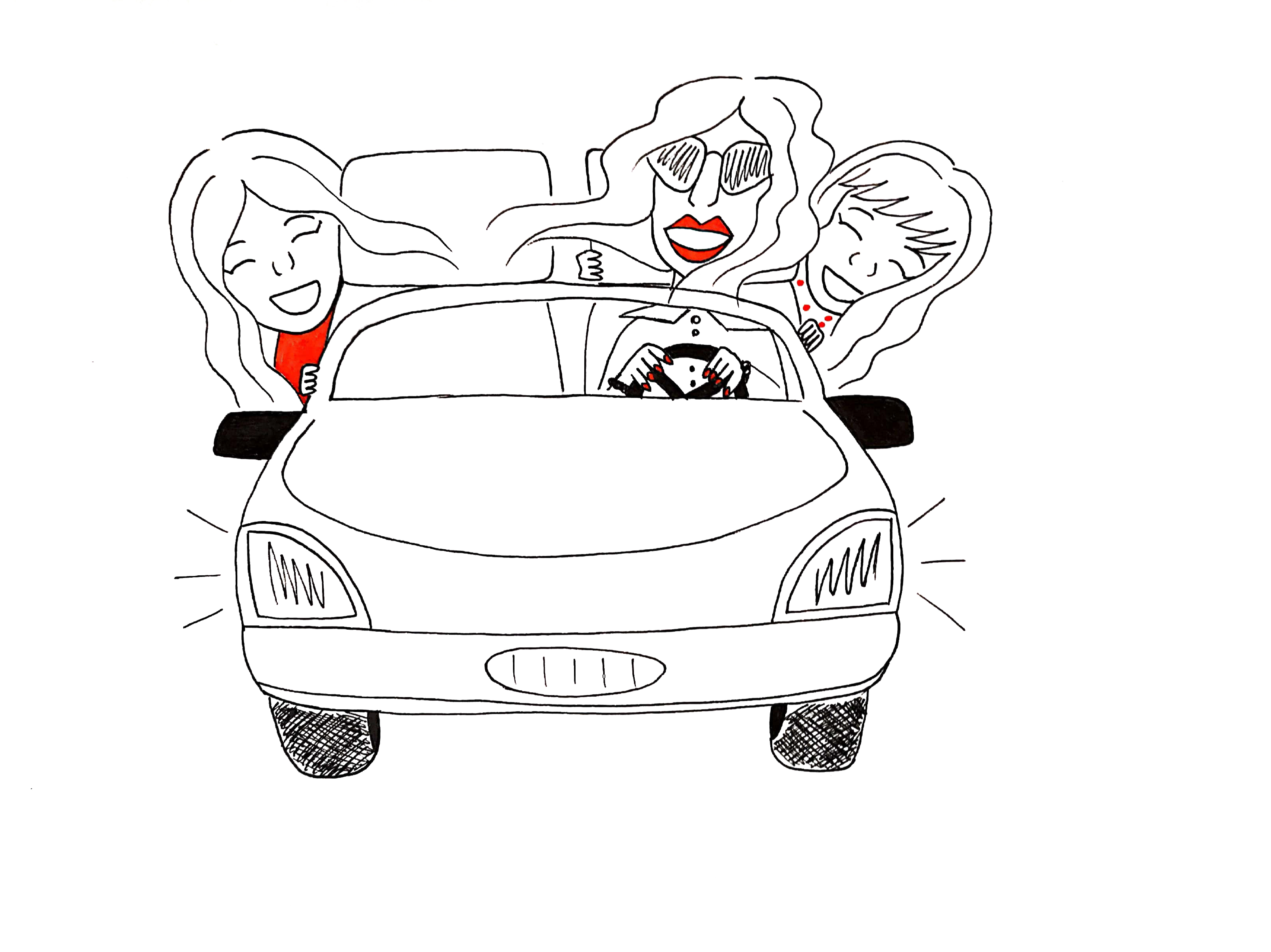12
Ott
era una volta uno stilista per cui andavo letteralmente pazza. Era giovane, bello. Era una promessa della moda italiana.
La fashion week di Milano era solo un pretesto per vederlo, per fare due chiacchiere con lui e portare a casa la cartella stampa su cui avrei lavorato giorno e notte per scrivere un pezzo meraviglioso, dedicato alla sua collezione.
Nell’ottobre del 2014, io e Giaco eravamo a Parigi. Non succedeva spesso, ma era la seconda volta che si assentava dal lavoro per accompagnarmi alla sfilata di Chanel, regalandomi, allo stesso tempo, un weekend in una delle città più romantiche del mondo.
Alloggiavamo in un albergo del centro vicino a Rue Cambon, la via simbolo di Coco, e Matteo aveva disegnato due abiti per me. Un completo viola — pantaloni e blusa — in stile Saint Laurent, e un tubino con la crinolina — corpetto in pizzo, gonna in tweed — da abbinare a quattro paia di suole rosse, gentilmente offerte dalla maison Christian Louboutin.
Quello era il periodo felice in cui Loubi metteva a disposizione le sue scarpe per le mie fashion week: a volte non mi sembra vero che ho preferito diventare una scrittrice.
Anzi, a pensarci bene, credo che lo decisi proprio quella sera. Mi lanciai e scrissi un articolo che riassumeva la mia esperienza a Parigi, protestai sul fatto che non ci fosse il bidet in bagno e aggiunsi — senza usare alcun nesso logico — che era giunto il momento di tornare su quel libro che avevo lasciato in un cassetto.
Uno dei primi commenti che ricevetti su quel post, era di Valeria, una ragazza che non mi aveva mai scritto prima. A colpirla non era stata la mia dichiarazione artistica, ma la faccenda del bidet. Mi disse che probabilmente i parigini non avrebbero gradito.
Non stavo dicendo una bugia e poi non potevo tagliare la parte del bidet: era la più divertente del pezzo. Temporeggiai, risposi che ci avrei pensato. Aggiunse che mi seguiva da un po’, che aveva letto i miei articoli dedicati al giovane stilista che le erano piaciuti, e mi confessò di conoscerlo da quando era piccola, i loro genitori erano amici. Ma tu pensa il mondo quanto è piccolo, pensai.
E così, succede che ci sono persone che entrano nella tua vita per caso, a volte per una coincidenza, a volte per un bidet: così ho conosciuto Ringhio.
Valeria aveva vissuto a Londra per un po’, divideva l’appartamento con Nick, il primo batterista dei Jamiroquai, colui che oggi definisce come un fratello. Dipingeva, più di quanto non lo faccia oggi, e aveva organizzato un paio di mostre con le sue opere: una alla Brick Lane Gallery, l’altra nella White Gallery, erano le più quotate della città. Furono quegli anni a suggerirle che non poteva privarsi dell’arte. Tornò in Italia e comunicò ai genitori che non aveva intenzione di frequentare giurisprudenza e che si sarebbe trasferita a Viterbo per prendere una laurea in Beni Culturali.
Organizzò una mostra anche nella sua nuova città, mi invitò, ma non potei andare. Decisi ugualmente di dedicarle un articolo sul blog.
Valeria aveva iniziato a dipingere per uscire da un momento duro della sua vita.
Desiderava esprimere la sua arte in modo che anche il padre, non vedente, potesse recepirla. Le tele con le braccia di cartapesta furono il mezzo materico con cui sottolineare che nonostante le tante difficoltà, cercare di rendere la vita meravigliosa è un’esigenza.
La conobbi fisicamente l’anno successivo, in occasione di una calamità naturale. Dopo un terremoto di magnitudo 6.1 che colpì l’Emilia Romagna nel 2012 — per essere esatti.
Valeria, all’epoca, era già la fidanzata di Furio, e siccome Furio aveva avuto esperienze di restauri importanti all’Aquila, il comune di Sassuolo aveva richiesto i suoi servigi per una perizia al Palazzo Ducale, appartenuto alla famiglia d’Este.
Ci eravamo dati appuntamento in un bar di Piazza Piccola, quello sotto il campanile, alle quattro in punto. La scuola delle bimbe era a pochi metri da lì, sarei stata puntuale. O quasi.
I rintocchi dell’orologio — più in lontananza del dovuto — mi ricordavano che ero in ritardo. Presi Emma e Carola per mano, mi inventai una gara, un gelato come premio e di corsa raggiungemmo il bar.
C’era solo una ragazza seduta a uno dei tavolini, con una tela 100×80 tra le mani: Valeria. Aveva viaggiato in treno con quell’oggetto voluminoso perché desiderava che avessi uno dei suoi quadri. Mi commossi. Gli presentai le bimbe, lei mi presentò Furio, e al momento dei saluti, mi dispiacqui di aver passato così poco tempo con lei. Allora non sapevo che le nostre strade sarebbero diventate una sola. E nemmeno avrei immaginato che un paio di mesi più tardi, chiacchierando al telefono, potesse uscire una proposta d’affari che si sarebbe concretizzata.
Valeria si trasformò in Ringhio il giorno in cui cominciò a lavorare con me.
Amiche, colleghe, compagne di sventura legatissime. Ma anche nei migliori rapporti può succedere di litigare. E mica solo una volta.
La lite più furiosa di tutte, risale a un anno fa, durante la mia gita in Giappone con Antonino. Seppure nutra un amore smisurato per il mio amico stilista, la lontananza da casa, il fuso orario e la mancanza di ore sonno mi avevano resa un tantino intrattabile.
Un giorno, chiamai Valeria per parlare di alcune cose di lavoro, ma il suo tono di voce mi sembrava distaccato, non era quello affettuoso a cui ero abituata. Eravamo alle solite, pensai, ce l’ha con me e non vuole dirmelo. Non ricordavo di aver detto o fatto qualcosa che l’avesse offesa, così partii in quarta.
“Dove ho sbagliato stavolta?” sbottai.
“Ma che stai dicendo amo?”
La lite ebbe inizio più o meno o così e andò avanti per un po’. Lei urlava, io pure.
Ma dopo tre minuti di grida isteriche, mi accorsi che le frasi che tutte e due stavamo ripetendo erano le stesse: “non interrompermi! Mi fai finire il discorso?”
Ebbi un’intuizione: le mie e le sue parole arrivavano in differita e il ritardo rendeva tutto confuso e incomprensibile.
“Stop!” urlai. “Vale, aspetta, ascoltami: le parole arrivano in differita: dobbiamo aspettare dieci secondi tra una battuta e l’altra o non ci capiremo mai.”
La risata che ne seguì, invece, arrivò in tempo reale: facemmo la pace.
E in fondo, cosa sarebbe la mia vita senza Ringhio?
Una volta, per esempio, durante il periodo primaverile, mi sentivo un po’ spossata. Ne parlai con lei, che oltre a essere una tuttologa con il pollice verde, è anche un’appassionata di omeopatia.
“Amo, sai cosa ti devi prendere?”
“No, dimmi…”
“La rodiola”
“La robiola? Fa bene?”
“RO-DIO-LA.” disse calcando la d. “La rodiola è una radice che veniva data ai soldati romani durante le battaglie.”
In effetti, la vita di tutti i giorni non era poi così diversa.
“Rinvigorisce corpo e mente e riduce la stanchezza.”
Mi convinse, la provai, ma dopo una settimana, mi chiesi in quale momento della battigia, i soldati assumessero la rodiola. Sicuramente dopo, a conflitto finito, creava sonnolenza: smisi di prenderla.
E se i suoi consigli in materia omeopatica lasciavano un po’ a desiderare, quelli di make-up, invece, restano tuttora infallibili.
Lei ha un debole per tutto ciò che si può applicare sul viso: creme, maschere, fondotinta, polveri, ombretti, mascara, matite, rossetti, blush e illuminanti.
Lei non è solo un’esperta, è pure una pittrice e quando assiste alle mie sedute di trucco, si mette le mani nei capelli.
A volte credo di non essere degna di quel profilo autore da beauty reporter su Glamour.
Ringhio mi corregge, mi insegna a sfumare l’ombretto, a disegnare le sopracciglia allungando la coda, mi consiglia il rossetto in base alla consistenza e ai pigmenti che lo compongono. E a volte, ricorrendo pure alla saliva, elimina gli eccessi di blush che ho lasciato sugli zigomi.
Seppure grazie al suo prezioso contributo — col tempo — abbia decisamente migliorato la mia tecnica, una volta le chiesi: “Perché una volta non mi trucchi tu?”
“Mi piacerebbe moltissimo.”
Fu lei a informarmi che quel momento era giunto, lo fece per telefono.
“Amo sei seduta?”
“Sono sulla scala a scrivere.”
“Ho ricevuto una mail da Yamamay, mi chiedono se vuoi fare una foto che sarà condivisa sui loro profili social…”
CONTINUA…
Illustrazione: Valeria Terranova