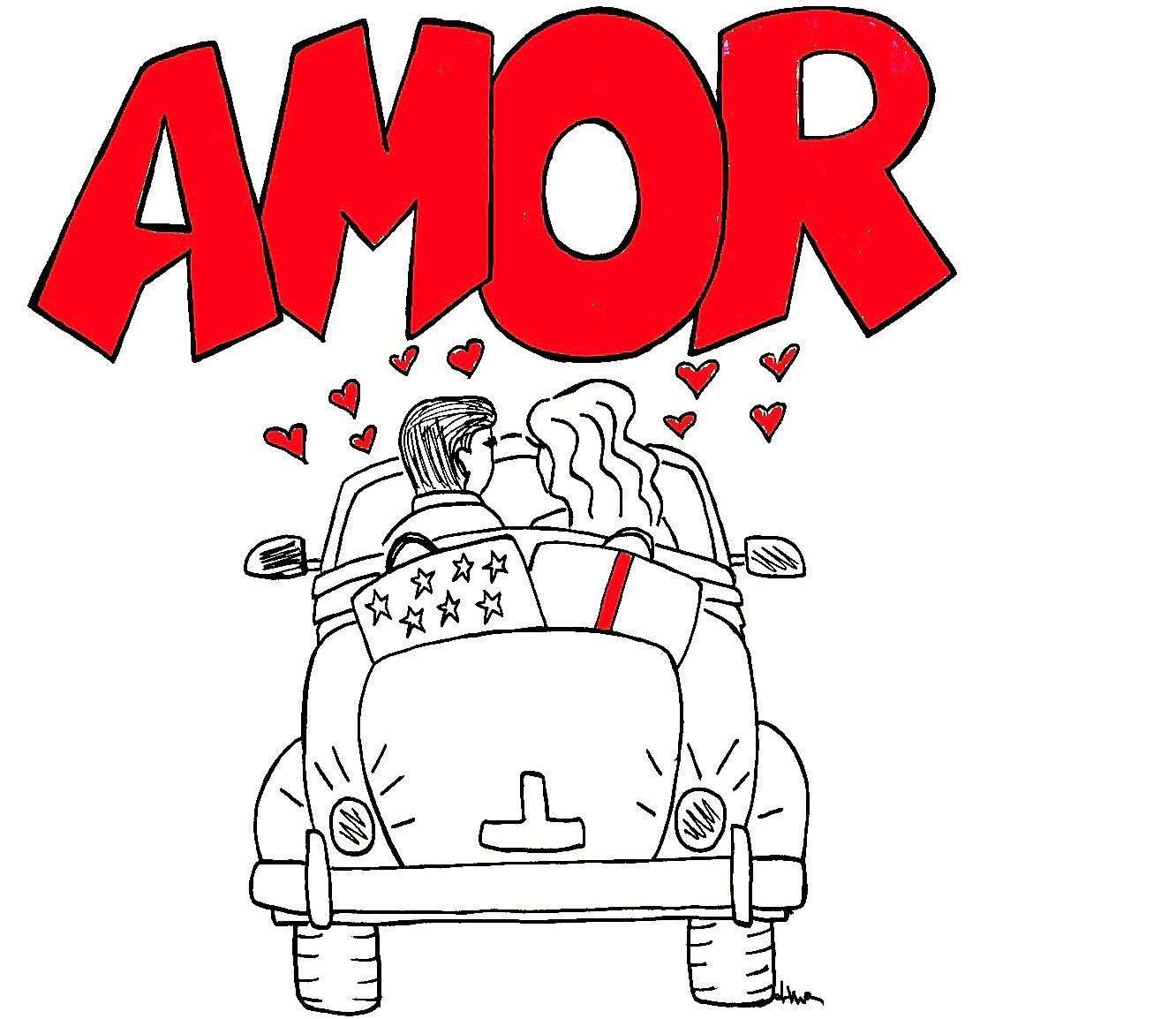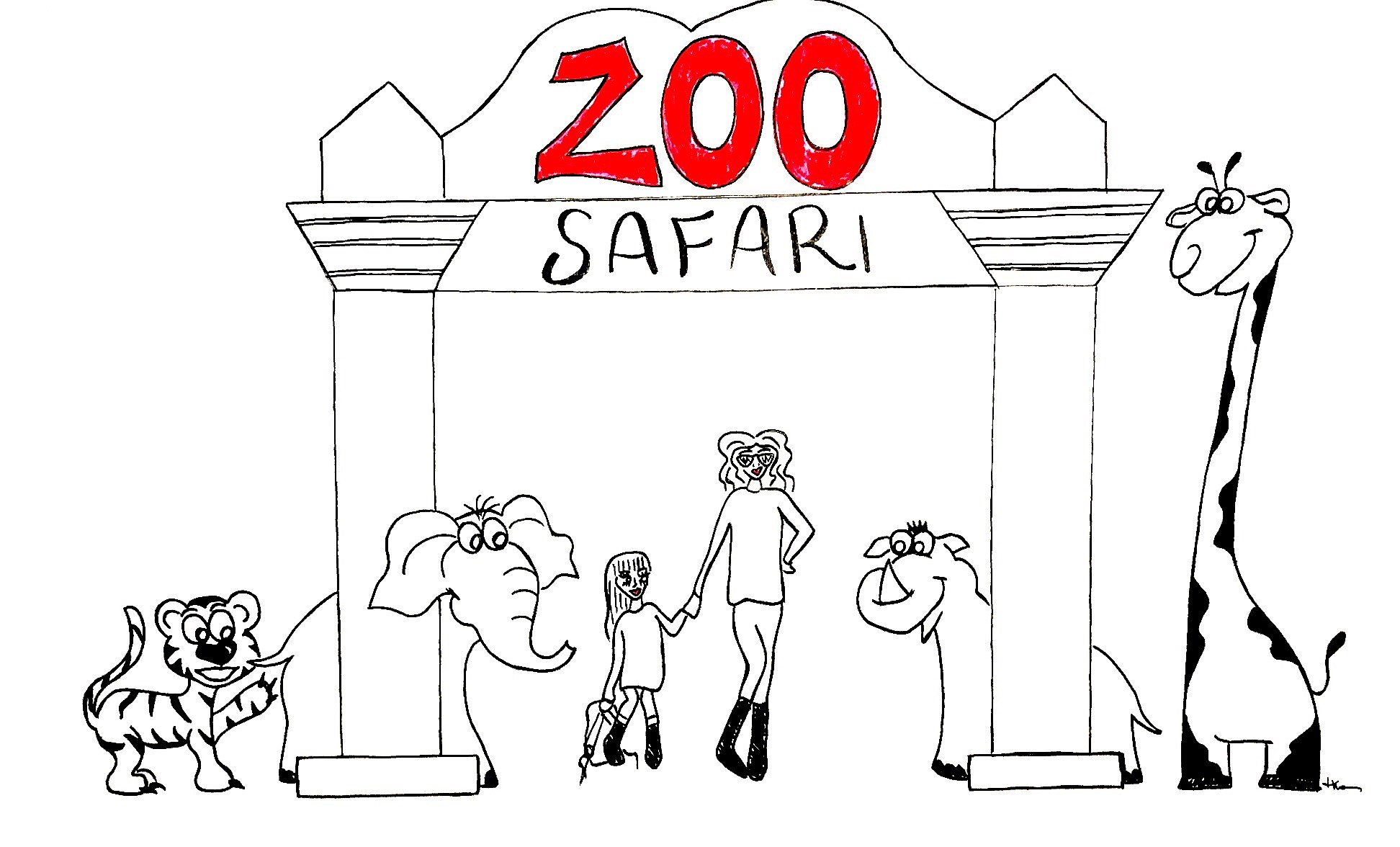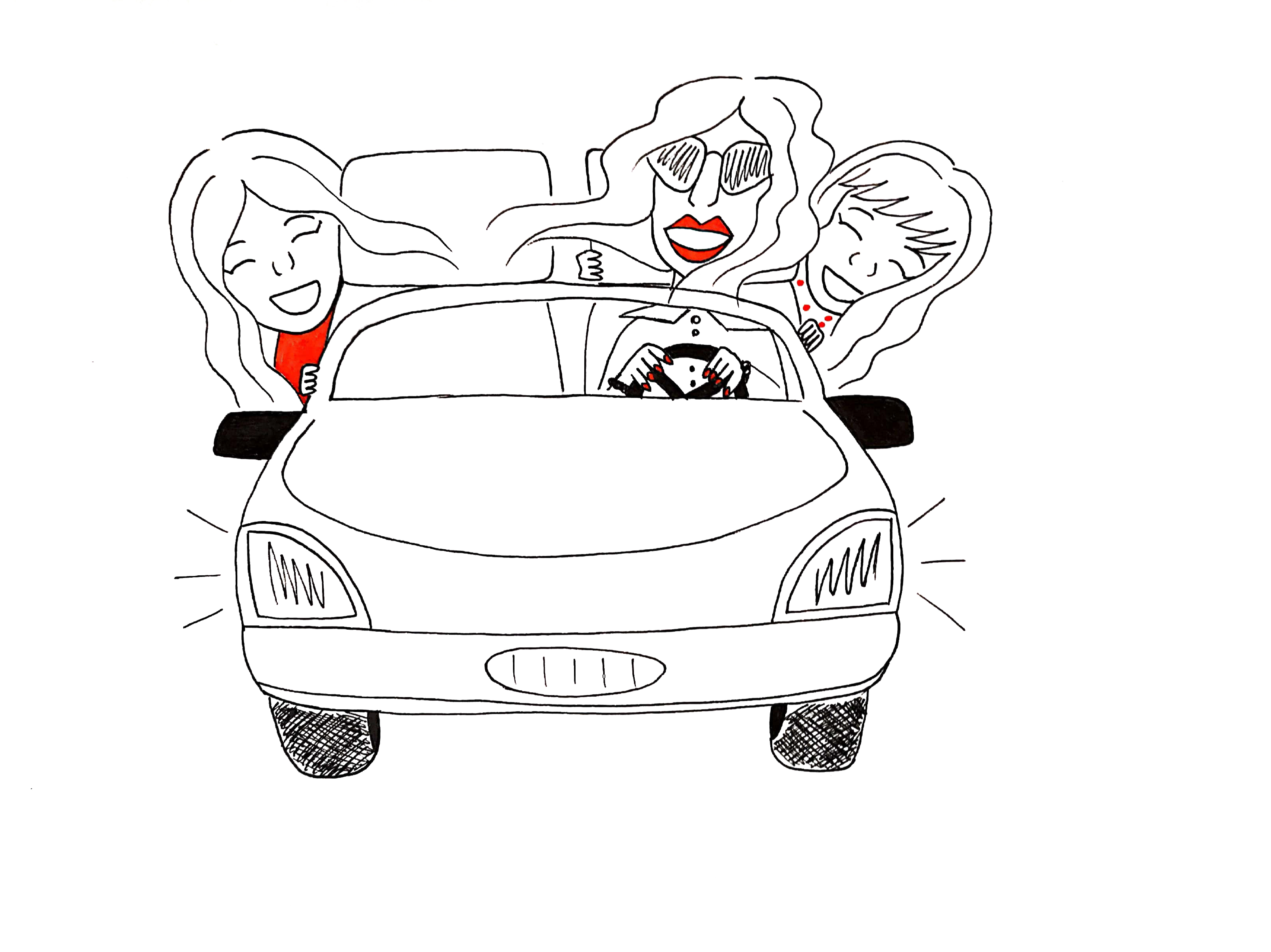l mio abito da sposa è finito in un cellophane gigantesco. È sporco di trucco, di vino, di erba. Sembra il costume di Cenerentola dopo giovedì grasso: a festa finita, sono tutti uguali. Faccio un sospiro, afferro i manici della borsa e lo scarico dall’auto. Lo guardo ancora una volta e dico: “anche questa è andata.” Ora, mi metto a preparare le valigie. È la prima volta che ne faccio una con la fede al dito. Stendo la mano per ammirarla, e poi, sento quello sciame di farfalle nello stomaco. Quell’eccitazione che ti prende quando realizzi che una cosa ti piace, anche se ha un suono strano: ora, sono la moglie di Giaco. Un po’ come ‘la donna der Puma’. Pieraccioni – Fuochi d’artificio – 1997. Mi scappa un sorrisetto. Sono di fronte alla scatola dei miei sandali preferiti: questi vengono con me, dico mente mi arrampico per prenderli. Ho sempre pensato che le scarpe comunichino tra loro. Alcune raccontano di essere state a Miami, New York, Londra, Parigi. Ogni suola desidererebbe camminare per le vie romantiche di città sconosciute, ma posso portare solo qualche paio, devo fare attenzione agli abbinamenti. Da una parte mi dispiace non aver scelto una località di mare – a parte il seno sciolto, avrei superato la prova costume alla grande – ma ho preferito che Giaco tornasse in un posto speciale che ha visto una volta soltanto: in quinta elementare.
La Paola. La mia migliore amica, quella con la camicia a fiori: è stata lei a portarmi a Roma per la prima volta. Avevamo vent’anni ed eravamo libere di fare ciò che volevamo. Più o meno. La zia della Paola ci avrebbe ospitato nella sua grande casa vicino al Vaticano. Che si chiamasse Suor Maura e che l’alloggio fosse un istituto religioso con regole e orari da rispettare, me lo disse sul treno di andata, quando non potevo fare più niente per tornare indietro. Decisi di non saltare, ma solo perché Giaco era a casa ad aspettarmi. L’autobus ci fece scendere ai piedi di una lunga salita. La facemmo di corsa, eravamo curiose, eccitate, e arrivammo davanti alla Congregazione Figlie Della Provvidenza. E davanti all’insegna, pensai che se così doveva essere, un po’ di sana e divina provvidenza non mi avrebbe fatto male. Il posto era carino, c’era un bellissimo parco verde e un grande cancello che si chiudeva inderogabilmente alle 22. Dio è ovunque, anche nelle clausole vessatorie. Avevamo capito che se volevamo divertirci, dovevamo vivere di giorno. Sveglia alle sette. Pranzo alle dodici. Cena alle diciannove. Stavamo in giro tutto il giorno. Monumenti, chiese, musei, negozi e librerie. Poi, il destino ci condusse nella Fabbrica di San Pietro, e lì c’era Mario: una delle guide della Basilica. La Paola perse la testa. Era il suo tipo: belloccio, intellettuale. Anche lui sembrava esserne attratto, e per stenderla culturalmente, ci deliziò con una bellissima lezione sulle Sacre Grotte Vaticane e sulle tombe dei Papi. Quello che in un’aula scolastica avrebbe potuto uccidermi, qui era stranamente interessante, ma solo per esigenze di copione. Aspettammo la fine del suo turno e davanti a un caffè, ci invitò a uscire la sera successiva. Nessuna di noi aveva trovato il coraggio di confessare che vivevamo in condizioni di semi-clausura, cercammo di stare sul vago, suggerimmo un’apericena e lui fu d’accordo. Alcatraz chiudeva alle dieci: potevamo farcela. Erano le sette quando il taxi si fermò davanti a un locale con un insegna rossa: Nuvolari. Pagammo la corsa e raggiungemmo Mario, che aveva portato un amico. Per ironia della sorte, Simone pure lui, era carino, simpatico e voleva fare l’attore. Fu una bella serata. Ci restava una sola notte nella capitale – che era più un’idea – e volevamo rivederli. L’indomani, andammo a cena alle sei. Alle sei e trentacinque lasciammo il ristorante.Girammo la città in macchina e dieci minuti prima del coprifuoco, ci riaccompagnarono davanti al grande cancello, dove, impacciate e divertite, raccontammo la verità. Da allora abbiamo continuato a sentirci, a vederci. Siamo rimasti amici, Mario è anche venuto al nostro matrimonio. Simone invece non ce l’ha fatta, ma ci ha promesso una cena in un ristorante speciale. Non vedo l’ora. L’agenzia ha prenotato un albergo che si trova di fronte alla Fontana di Trevi. Abbiamo espressamente chiesto una camera con vista e ci hanno promesso quella che ha avuto Bon Jovi. Ma non abbiamo ancora capito se abbia la vista oppure no. Arriviamo nel tardo pomeriggio, ci saranno almeno trenta grandi e la piazza è gremita di turisti. Creare un varco per raggiungere l’ingresso non sarà facile, ma noi ci riusciamo. Ci presentiamo alla reception come marito e moglie, e noto che anche Giaco ha qualche difficoltà nel pronunciare quelle parole. Sembra Fonzie quando non riesce a chiedere a scusa. Consegnamo i documenti e un tizio gentile si offre di accompagnarci in camera. Dice che siamo al terzo piano e ci fa strada verso quello che vorrebbe essere un’ascensore. Odio gli ascensori vecchia maniera. Anzi, mi fanno paura. Non li sopporto perché sembrano inaffidabili. E forse lo sono. Questo è quasi un montacarichi. Deglutisco nel tentativo di farmi coraggio, un passo e sono dentro. Adesso chiudo gli occhi. Non pensare alle funi. Non pensare alle funi. Non riesco a non pensarci.
Per qualche strano miracolo – forse le Suore della Provvidenza – l’ascensore arriva al terzo piano. Ci scansiamo per poter aprire le due porticine, spingiamo la maniglia della lastra di metallo e usciamo. Sono salva. Isac – glielo leggo sulla giacca – ci fa entrare nella nostra stanza. È piccola, è deliziosa e ha una vista che non scorderò più. Ma chi se ne frega di come si accende la luce, la tv, o di com’è il bagno. Io voglio vedere la Fontana di Trevi, la Fontana di Fellini. Mi affaccio alla finestra: c’è un fiume di gente qui sotto, ed è qui per ammirare ciò che io vedo dalla mia finestra: è un sogno. Lì, su quel piccolo davanzale, mi immagino come Anita Ekberg a sguazzare nell’acqua e non posso fare a meno di chiedermi: se lo facessi anch’io, potrebbero arrestarmi? Meglio non saperlo. Giaco va a farsi una doccia e io finisco di sistemare i bagagli, ma sono già le sette e tra un’ora abbiamo appuntamento con Simone e Mario, devo muovermi. Dopo quarantasei minuti sono pronta. Prendo la borsa, prendo Giaco e usciamo dalla stanza.
“Perché non facciamo le scale?” suggerisco.
“Hai paura anche di questa?” mi chiede indicando la vecchia carcassa.
“Preferisco le scale.”
“Dai, smettila, non puoi aver paura.”
“Ti ho detto che preferisco le scale.”
Giaco entra in ascensore e mi lascia lì: sul pianerottolo. I miei occhi si mettono a fissare i sandali e mi maledico per aver pronunciato quella frase con così tanto fervore. Controllo che non ci sia nessuno che possa vedermi. Guardo in alto, poi in basso: via libera. Ora, posso assumere la mia andatura da papera che mi garantisce maggiore stabilità, aggrapparmi alla ringhiera e tamponare la sudorazione con un Kleenex. Forse, ho le stesse probabilità di riuscita dell’ascensore. Ma lei arriva per prima. Fingo che il mio femore non ne abbia risentito, mi ricompongo e raggiungo Giaco nella hall che ha già chiamato un taxi. Sarà qui in quattro minuti. Il tempo necessario per dare una sbirciatina al negozio di scarpe che sta qui accanto: Sorè. Quel paio laggiù starebbe proprio bene con il vestito che ho stasera: un tubino rosso a longuette di Ferré, che mi ha prestato mia cognata. Lo voglio, non resisto. Entro, chiedo un 38, lo provo e lo tengo ai piedi. Infilo i vecchi sandali nella scatola, pago ed esco. Il taxi è appena arrivato. Dovrebbero invitarmi allo Show dei Record. Lascio la borsa in reception e salgo in macchina dove Giaco mi sta aspettando. I ragazzi sono a Trastevere.
“Perché hai cambiato le scarpe?” mi chiede.
“Amore! Te ne sei accorto? Mi commuovi!” dico svenevole, tentando di cambiare discorso.
“Le altre si sono rotte?”
Perché scervellarmi per cercare una scusa decente, quando è lui a servirmela su un piatto d’argento?
“Sì. Purtroppo per le scale. Erano i miei sandali preferiti.”
Lui mi guarda con la solita espressione. Quella del mistero. Quella del ‘ti ho beccato, ma preferisco lasciarti credere che me la sia bevuta’, e in amore si sa: è tutta una questione di sguardi. La macchina si ferma di fronte a Piazza Trilussa, Mario e Simone ci aspettano davanti alla fontana. Mi sono mancati. Anche Giaco sta bene con loro e sono curiosa di sapere se Simone mi ha accontentata. Mi abbraccia, mi strizza l’occhio e dice:
“Abbbella, ci ho pensato io.”
Giaco capisce che la mia folle proposta è stata accolta anche senza il suo consenso, ma invece di arrabbiarsi, si mette a ridere.
“Mi spieghi il gusto di andare a mangiare in un posto dove ti offendono?” mi chiede.
“Cosa dici? Stiamo parlando della Parolaccia, il ristorante de La Belva Umana, dove Villaggio e la Mazzamauro venivano coperti d’insulti, è un’istituzione, non possiamo non andare.”
“Quindi, Enrì famme capi’: noi pagamo e questi ce fanno ‘e battuttacce?” interviene Mario divertito.
“Ma lo fanno cantando, suonando, improvvisando stornelli, sarà uno spasso.”
Dalle loro espressioni capisco che è più un sacrificio che un piacere, ma sono sicura che alla fine mi ringrazieranno. Entro decisa, accompagnata dai miei tre cavalieri. Un cameriere ci fa sedere dicendoci le cose peggiori.
“Che te sei messo un televisore disturbato?” chiede a Giaco che indossa una camicia a righe.
“E te? Chi saresti? La signora in rosso senza zinne?”
Ecco questa direi che per me. E mentre Mario si lascia scappare una fragorosa risata, arriva una battuta anche per lui:
“Che ti ridi? Ciai più corna che capelli te! Mettete seduto e non rompere li…”
Simone è l’unico a cui rimane un minimo di dignità.
“Enri, volevo ditte: io la storia che nun magni carne, nun je la direi…” mi suggerisce preoccupato.
“Ma no, figurati, vedrai che capiscono.”
Chiamo il cameriere che ci ha fatto sedere e mi raggiunge.
“Senta, guardi, io sono vegetariana.”
Giaco, Simone e Mario si guardano in modo complice, curiosi di vedere la sua reazione. Il tizio sembra non aspettare altro.
“E c’hai ragione! Hai visto più piselli te che ‘r minestrone de mi’ nonna.”
Il mio tavolo si è trasformato in una convention della risata con lacrime, e io mi unisco. Questo è solo l’inizio di una serata esilarante che ricorderemo per sempre. La sera, mentre cerco di addormentarmi, ripenso, alla mia nuova vita, a tutto quello che verrà: sono troppo eccitata per prendere sonno e l’acqua che sgorga dalla Fontana – anche di notte – di certo non aiuta, ma se c’è riuscito Bon Jovi, posso farcela anch’io. Bacio Giaco che ha già chiuso gli occhi da un pezzo, mi giro su un fianco e cerco di imitarlo.La nostra luna di miele è giunta al termine, le valigie sono chiuse. Saluto la Fontana da quella finestra per l’ultima volta e usciamo dalla stanza.
La paura dell’ascensore non è passata, mi rassegno e lei si apre. Anche questa volta, contro ogni pronostico, arriva al piano terra. Paghiamo gli extra e chiamiamo un taxi per la stazione, ma prima di salire, chiedo a Giaco di passare in via del Babuino per una piccola sosta: voglio vedere la boutique di Chanel. E lì in quella via che si affaccia su Piazza del Popolo, incontro Kim Rossi Stewart. È come avere di fronte un vassoio di pasticceria mignon e non poterne abusare, ma il matrimonio è anche questo.
Illustrazione: Valeria Terranova