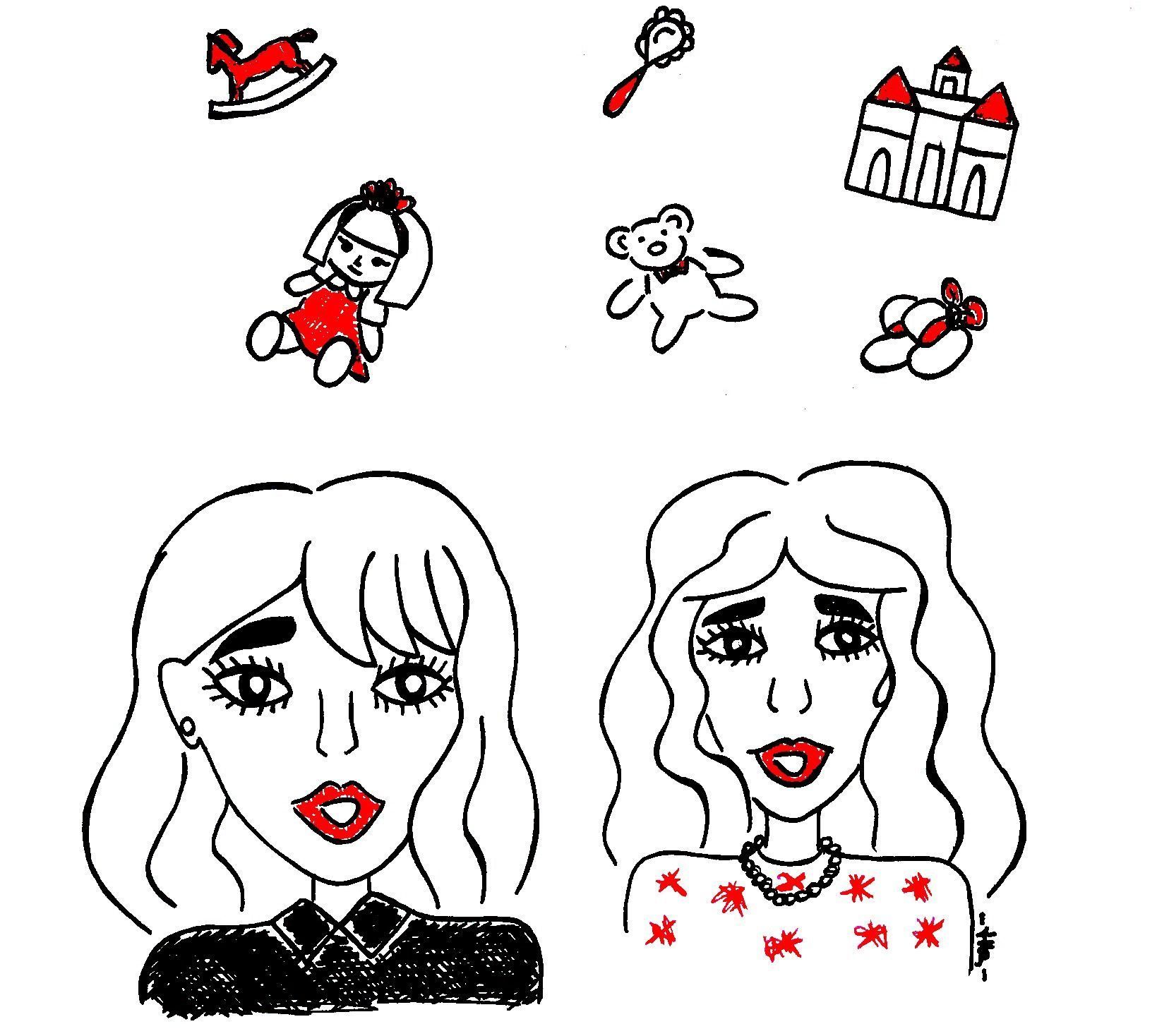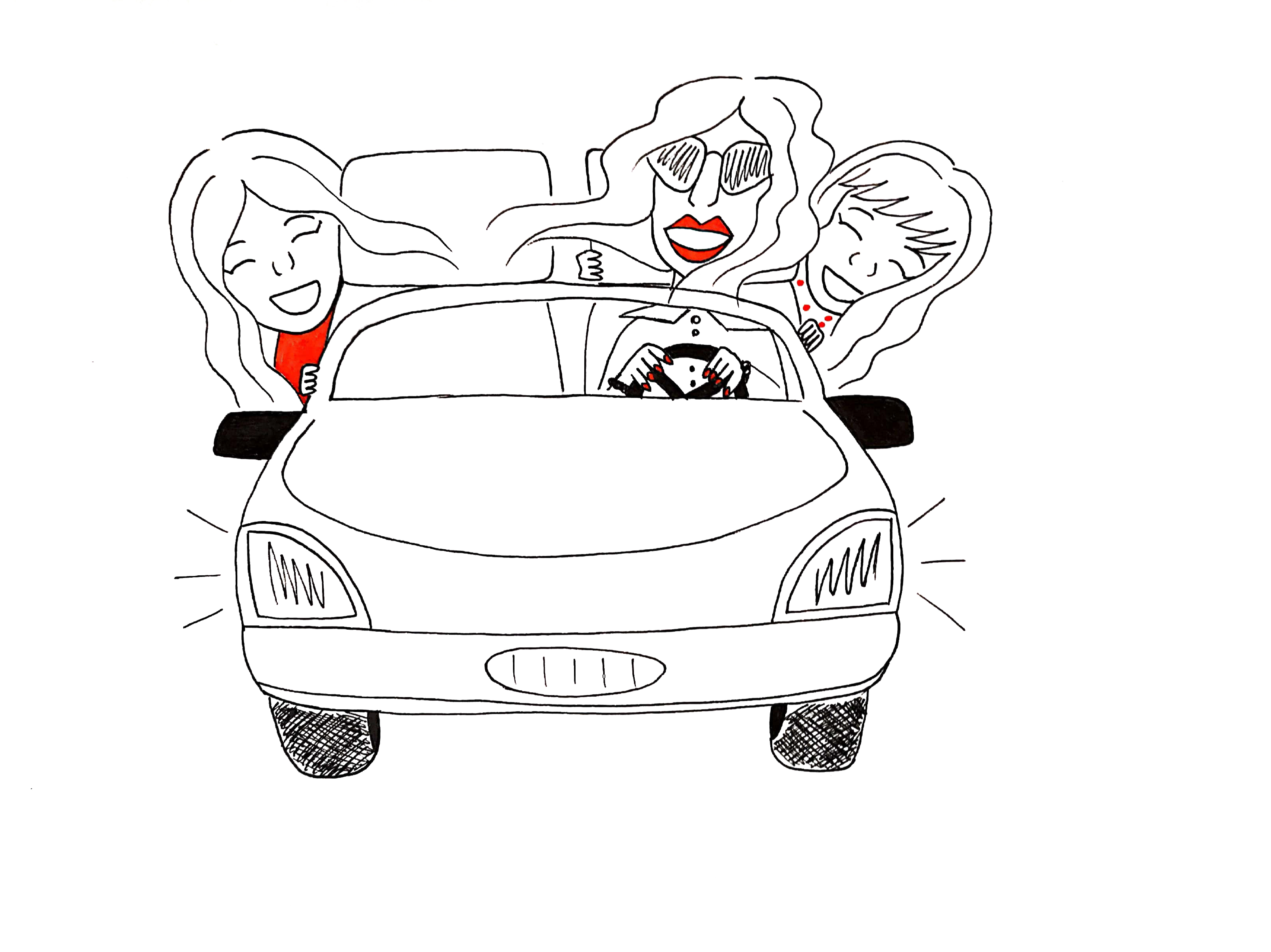arigi. Tutte le volte che sono stata qui, era per una ragione: Chanel. Le sfilate di Chanel. Ma il mio vero obiettivo era un altro: convincere qualcuno del personale a condurmi nell’appartamento di Coco. Purtroppo, anche con il francese ho qualche problema, e non nego che la prospettiva più realista sia sempre stata quella di introdurmi in modo furtivo nella sua abitazione: mi è solo mancato il coraggio. La maggior parte delle sfilate di Chanel si tiene al Grand Palais, un enorme padiglione espositivo dal nome altisonante come la sua struttura: facciata in pietra, tetto in vetro e acciaio, e imponenti colonne ioniche. Ricordo bene la prima volta che lo vidi, nonostante un vero e proprio diluvio universale, rimasi senza fiato. Ma non sarebbe stata un po’ di pioggia a scoraggiare me e Giaco, e al nostro arrivo, i fotografi si erano scatenati. Ci sembrava strana una tale attenzione, ma eravamo vestiti bene, eravamo bellocci e poi, eravamo da Chanel. Sorridevo, sfoggiavo la mia mise soddisfatta e mi sparavo le pose. Non ricordo così tanti flash nemmeno il giorno del mio matrimonio. Poi, alzando la testa, avevo notato la scritta che stava appesa sopra di me: BACKSTAGE.
“Forse abbiamo sbagliato l’entrata.”
Il mio bisbiglio all’orecchio di Giaco ci aveva rimesso in moto: nella direzione opposta, dopo esserci congedati con una sorta di inchino. Ma dall’altra parte, era successa la stessa cosa: ci fotografavano anche lì e per un attimo, ammetto di essermi sentita una super gnocca. Il Grand Palais era stato allestito come una piccola valle di campagna, con fascine di paglia, balle di fieno, fiori di campo, c’era addirittura un fienile in legno, e poco più in là, era stato preparato un palco, probabilmente destinato a una star che si sarebbe esibita, anche se ancora non sapevamo chi fosse.
Lo scoprimmo poco più tardi, all’assegnazione dei posti: in alto, in fondo, in fondo. Mi ero consolata guardando le dieci file di posti dietro di noi, forse occupate da alcune comparse, con l’intenzione di farci sentire meno peggio.
“Non è giusto!” avevo esclamato.
E quando Lily Allen — di cui riuscivo a vedere solo le spalle — si mise a cantare Not Fair, nel bel mezzo della sfilata, capii che il pezzo era quasi certamente dedicato a noi. Ho fatto tesoro dei piccoli incidenti di percorso, di quel briciolo di esperienza accumulata con una sola fashion week parigina e ora, che mi è stata offerta una seconda occasione e una seconda sfilata, vorrei che tutto filasse liscio. La terza camera d’albergo che mi è stata assegnata — dopo averne cambiate due, causa capienza ristretta del guardaroba — mi soddisfa. Come la mise che ho scelto: un abito con crinolina in tweed e bustino in pizzo, creato dal mio amico stilista Matteo. Un cappello a forma di cuore, ideato da un altro amico stilista che si chiama Francesco. Una giacca di John Galliano classe 1989, prestatami da Cesare, uno dei miei pusher ufficiali di abiti e accessori. E un paio di sandali di Louboutin spediti dall’ufficio stampa di Parigi. Di mio non ho niente, giusto le mutande e la borsa: una 11.12 in tessuto, con applicazioni di ispirazione russa. Questa combinazione, che avrei giudicato azzardata fino a qualche anno fa, ora mi piace, ha uno stile tutto suo. La macchina ci aspetta davanti all’ingresso dell’hotel, saliamo, forniamo la destinazione all’autista e ci mettiamo in marcia.
“Giaco, mi raccomando, stavolta dobbiamo azzeccare l’entrata, non ripetiamo la figura della volta scorsa, okay?”
“Ti ricordo che la volta scorsa, sei stata tu a insistere, io ti ho solo assecondato…”
“Appunto, non assecondarmi più. Sai che ho dei limiti con l’orientamento, quindi, portami nel posto giusto senza ascoltare i miei suggerimenti. Un’altra cosa… perché alzi gli occhi al cielo?”
Mi guarda divertito, ma è un divertito diverso dal solito standard, sembra quasi esasperato dalle mie raccomandazioni.
“Un’altra cosa…” dico per riprendere il filo.
“Fammi indovinare: se dovessero fotografarti, devo immortalare il momento, giusto?”
“Come fai a saperlo?”
“Me lo hai già detto quattro volte.”
“Quindi hai capito?”
Visti da fuori, su quei sedili posteriori, io sono la versione femminile di Furio di Bianco, rosso e Verdone, Giaco sembra Magda, con quell’espressione traducibile in non ce la faccio più! e un po’ lo capisco. Arriviamo al Grand Palais con un po’ di anticipo e il piazzale è già gremito di gente. Sento i battiti accelerati, l’ansia, la frenesia, ma per esigenze di copione, scendo dall’auto fingendomi abituata a questo tipo di situazioni. Giaco, invece, sembra veramente a suo agio, ma forse è soltanto felice di non essere più solo con me, su quella macchina che è appena andata via. Mi prende per mano e mi conduce davanti all’ingresso, questa volta senza sbagliare. Lo ringrazio. Per questioni di immagine, aspettare con le mani in mano è catastrofico — anche se si indossano gli occhiali da sole — ecco perché tutte le persone che aspettano qualcuno o qualcosa hanno sempre il telefono in mano: per dare l’idea della persona impegnata. E ora anch’io, che l’ho appena recuperato dalla borsa, ho un aspetto decisamente interessante. Dopo quattro secondi: i fotografi si fiondano su di me come i piccioni di Piazza San Marco: è l’apoteosi. Ma Giaco, che dovrebbe essere qui vicino a me, a immortalare questo momento, è al telefono. Lo guardo, lo fulmino. Lui apre il braccio sinistro verso l’esterno, con il destro mi mostra il cellulare e conclude con un labiale che dice LAVORO. Scandito bene. Chiedo ai fotografi di aspettare un momento, indicando mio marito che è impegnato al telefono, ma quelli se ne vanno: è arrivata Chiara Ferragni. Lo sapevo! Tutta colpa di Giaco e della sua telefonata di lavoro. In effetti, non saremmo proprio qui se non ci fosse il suo lavoro — con il mio reddito avrei giusto potuto offrire una gita sulla Senna.
Dobbiamo solo aspettare un nuovo stormo di fotografi, ecco: quello che sta arrivando proprio adesso. Giaco si apposta, ha le movenze di uno di loro, si abbassa e inizia a scattare.
“Sono pettinata?” chiedo con voce stridula, mentre mi sbrigo a mettere insieme una posa naturale.
“Sono pettinata sì o no?”
I fotografi sono sempre più vicini.
“Con quel cuore in testa, i capelli non si vedono.”
Appena in tempo. Sorrido e vengo accecata da una sagoma circolare che riflette la luce: sembra una cosa seria. I fotografi che stanno davanti a me sono professionisti, uno di loro mi chiede di seguirlo per condurmi davanti a un fondale bianco. Mi dice che lavora per Elle: sono emozionata. Mi volto di nuovo a cercare lo sguardo di Giaco, che è riuscito a intrufolarsi.
Mi concentro sul cerchio di Domopak che sta lì al mio fianco e faccio del mio meglio per nascondere l’imbarazzo. Sto andando bene, anche io sono entrata nella parte e sono più sciolta. I fotografi sono tanti, ne arrivano altri e mio marito è sempre sul pezzo, fino a che qualcuno non cerca di allontanarlo.
“No scusi, è mia moglie, se permette, la fotografo anch’io.”
Così: in francese perfetto — anche se assomiglia più a dialetto emiliano. Il fotografo capisce la sua protesta, gli sorride e gli fa cenno di continuare. Dopo la sfilata, dopo un taxi, dopo una cena romantica, io e Giaco siamo a tavola, aspettando il conto. Siamo vicini e guardiamo le foto di quella giornata.
È quasi mezzanotte, il tempo sembra volare.
Non so come vi viene, ma lo dico così, sorteggiando l’ultima goccia di vino.
“Un giorno scriverò un libro che parla di te.”
“Un manuale per mariti e fidanzati costretti a fotografare mogli e fidanzate in condizioni estreme?”
“Simpatico…”
“Scrivilo! Sarà un best seller.”
Illustrazione: Valeria Terranova