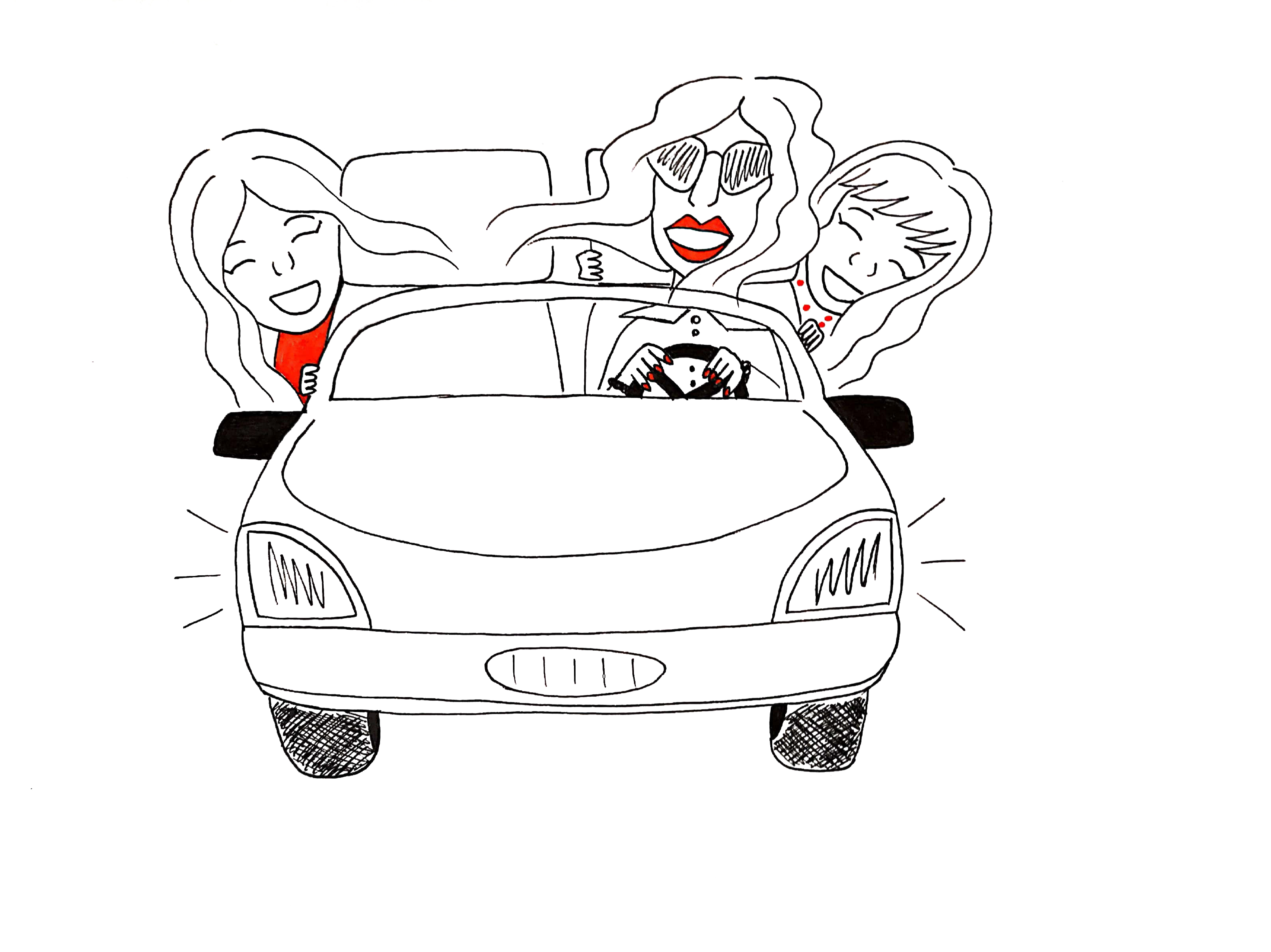asa dolce casa. È lì che vorrei essere.
È questo che mi dico mentre salgo in macchina, alla fine del mio primo giorno di lavoro, che definire catastrofico è quasi un eufemismo.
Prendo il telefono e chiamo Michele.
“Tesoro! Allora com’è andata?” esordisce in tono goliardico, ignorando la mia terribile giornata.
“Un vero disastro. Il mio capo è una strega.”
“La signora Molinari? Ma non hai detto che era un tesoro?”
“Non parlo di lei, parlo di Olivia: la responsabile del reparto accessori. Credevo le servisse un braccio destro non un punching-ball…”
Michi scoppia a ridere.
“Descrivimela…”
“Lavora per Blumarine da dieci anni, è sposata, ha due bambini — questo l’ho capito da una sua telefonata a casa — e il gros-grain non le piace.”
“Il gros- grain chiarisce ogni cosa…”
“Spiritoso! Oggi stavamo lavorando a una sneaker e lei decide di completarla con un laccio di raso. Io mi permetto di suggerirle il gros-grain, perché è un materiale zigrinato che consentirebbe al fiocco di non sciogliersi, e lei ha cominciato a dare di matto. Mi ricorda che sono l’ultima arrivata, che ho tutto da imparare, che il gros-grain è più adatto per le finiture da sartoria e che è non è per niente elegante. Io volevo solo farle notare l’aspetto pratico: una scarpa che rimane allacciata non mi sembra un dettaglio trascurabile…”
Silenzio.
“Michi? Mi stai ascoltando?”
“Sì eccomi, stavi dicendo?”
“Lascia perdere, ho capito che il mio gros-grain non ti interessa, e poi sono già sotto casa. Toh, guarda, c’è la sua macchina…”
“La macchina di chi?”
“La macchina di Davide.”
Lo dico così, con una naturalezza quasi disarmante, ma la vera domanda è: come faccio a sapere che la macchina che ho di fronte è davvero quella di Occhi di cioccolato?
“E come lo sai?”
“Stavo giusto per chiedermelo…”
“Devi esserci salita, deve essere stato lui ad accompagnarti a casa venerdì, sforzati di ricordare…”
Michele continua a parlarmi, ma questa volta sono io a non essere interessata a suoi discorsi. Penso solo ai suoi occhi, al suo sorriso e, tutto a un tratto, la paura di incontrarlo si trasforma in impazienza. Devo vederlo.
“Okay, ora devo andare”, dico liquidando Michele, “se ci sono sviluppi ti chiamo.”
Chiudo il telefono, lo rimetto nella borsa e abbasso lo specchietto retrovisore per controllare il mio aspetto.
Nonostante la pessima giornata, non sono affatto male. Mi passo il rossetto sulle labbra e scendo dall’auto.
Decido di prendere le scale — l’ascensore mi provoca pensieri impuri — e arrivo al terzo piano. Devo scoprire qual è il suo appartamento.
Destra o sinistra? Destra. Anzi no, sinistra.
Mi avvicino alla porta e leggo il nome sul campanello: Miselli D.
D: Davide. Trovato!
Sapevo che il mio istinto aveva ragione: ora non mi resta che suonare.
Respiro profondamente, avvicino l’indice e avverto che sto trattenendo il fiato. Devo stare calma.
Il polpastrello si avvicina al pulsante di ottone, ma la paura mi fa indietreggiare.
Ossantocielo! Cosa ci faccio qui?
Mi allontano in punti di piedi e raggiungo di soppiatto la porta di casa mia. Vista da fuori sembro la Pantera rosa.
Apro la borsa, afferro le chiavi e le infilo nella serratura.
Sono dentro.
Casa dolce casa, ora sono al sicuro.
Questo il piano: la porta resta chiusa fino a domattina. Ora faccio la doccia, mi preparo la cena, e cerco un bel film d’amore alla TV, anzi no. Meglio un libro.
Ci vorrebbe una cosa tipo: ‘Come stare lontano da guai’ ma non credo che sia già stato scritto. E un motivo ci sarà.
Come posso stare lontana da lui?
Se Dio ci ha messo sullo stesso pianerottolo, qualcosa vorrà dire, no?
Il piano è cambiato: ora esco da qui, suono il campanello e gli dico che la serata di cui non ricordo assolutamente nulla è stata una delle più belle della mia vita. E poi lo bacio. Questo è sicuro.
Afferro la maniglia ed esco, dove ero rimasta? Sinistra.
Raggiungo la porta e senza esitare spingo l’indice sul campanello. Più che un trillo sembra una tromba da stadio: forse ci siamo.
“Chi è?” sento chiedere dall’altra parte.
È la voce di una donna.
Ossantocielo. È fidanzato?
Mi apre la porta una donna in vestaglia. Avrà più di sessant’anni e tutto può essere fuorché la sua fidanzata.
È sua nonna: non può essere altrimenti, e io devo farle una buona impressione.
“Buonasera, mi chiamo Eva. Abito qui da due settimane e non ci siamo ancora presentate.”
“Oh, piacere, Dolores!” esclama lei sorridendo mentre mi porge la mano.
Dolores? Questo non solo vive con la nonna, la nonna si chiama pure Dolores. Sono scioccata. E lui dov’è?
Cerco di sbirciare dentro casa, ma la gigantesca cotonatura di Dolores me lo impedisce.
“Volevo solo farle sapere che se dovesse servirle qualcosa a quest’ora sono a casa…”
“Ma che carina, grassie!” esclama pizzicandomi la guancia con le nocche, finendo quasi per staccarmela.
Prima che mi faccia fuori anche l’altra, devo chiederle della macchina.
“Senta, la macchina nera parcheggiata qui sotto è di suo nipote?”
Cosa sto dicendo? E se non fosse sua nonna? Se quella D non stesse per Davide ma per Dolores?Come ci entra questa signora di ottanta chili in un Porche Carrera?
“La Porss non è di mio nipote…”
Ecco, lo sapevo.
“È di Davide.”
Tombola!
“E lui c’è?” chiedo con voce tremante.
“Prova a suonare al suo campanello, è quello di fronte.”
Mi indica il lato destro: quello che il mio istinto aveva suggerito all’inizio.
Perché mi ostino a non dargli retta al primo colpo?
Mi volto di scatto e la porta si apre.
Occhi di cioccolato.
“Eva, ciao!”
È così bello che toglie il fiato.
“Ciao!” dico euforica tentando di smorzare l’imbarazzo.
“Dolores, tutto bene?” chiede lui avvicinandosi a noi.
“Ciao bell’uomo, questa ragassa voleva sapere se…” dice strizzandogli l’occhio.
“Dolores… è stato un piacere”, la interrompo. “Ora devo parlare a Davide di una cosa, ma se le servissero sale e zucchero… sa dove trovarmi.”
La congedo stringendole la mano, afferro Davide per un braccio, faccio due passi e siamo nel mio appartamento.
Chiudo la porta e lui si mette a ridere.
“Cosa volevi sapere?” mi chiede divertito guardandomi negli occhi.
“Niente…” tergiverso mentre lo faccio accomodare su una delle poltrone del salone. “Bevi qualcosa?”
Ecco, detta così sembro alcolizzata seriamente.
“Vuoi una Coca?” mi correggo alla svelta.
“Sì, volentieri.”
Mi segue in cucina, apro il frigo e prendo due lattine. Ma mentre gli verso da bere, sforzandomi di trovare un modo decoroso per parlargli del mio coma etilico, lui mi precede:
“I tuoi orsetti?”
Inzuppati di vomito — ma questo già lo sai — e chiusi in un cellophane alla Laura Palmer che ho consegnato in lavanderia stamattina, insieme al mio abito macchiato di rosso.
“Ce la faranno…” rispondo sorridendo.
“Vuoi che ti racconti di Milano, vero?”
Poi dicono che i calciatori sono senza cervello: tutte chiacchiere.
“Non mi ricordo niente.”
“Mi dispiace che tu sia stata male, e mi dispiace anche per i tuoi peluche, ma a parte ‘il gran finale’, ci siamo divertiti un sacco. Dico davvero…”
Non credo si stia riferendo al sesso. Se lo avessimo fatto, me lo ricorderei. Chi potrebbe dimenticarsi di uno così?
Meglio accertarsene.
“Mi ricordo del ristorante, ma uscita da lì: più niente.”
Mi verso un po’ di coca per fingermi impegnata.
“Niente niente?”
Dio, com’è imbarazzante.
“Potrei aver elaborato la mia versione dei fatti, ma non la giudicherei affidabile. La tua com’è?”
“La mia? Nitida e cristallina. Sono un giocatore, non bevo.”
Potrei sentirmi peggio?
Ora, mi darà tutti i dettagli della mia notte da leoni, e io morirò di vergogna. Qui: in mezzo agli scatoloni.
Appoggia il bicchiere sul tavolo, mi guarda e dice: “ti evito i dettagli che potrebbero annoiarti…”
No! Perché? Io voglio tutti i dettagli!
“Dopo il ristorante, ci siamo incontrati all’Alcatraz. Abbiamo ballato, hai bevuto un paio di cocktail e ti ho presentato ai miei amici. Mi hai anche detto di conoscere uno di loro: si chiama Paolo.”
Paolo? Io non conosco nessun Paolo. Vodka: devo dirti addio.
“Poi siamo usciti e tu avevi fame. Abbiamo preso la macchina, mi hai anche detto che è scomoda, e mi hai chiesto di fermarmi lungo la strada, davanti a un chiosco di patatine fritte.”
Ecco cos’era quella macchia sul vestito: ketchup.
Mi metto a sorseggiare nervosamente.
“Hai voluto che ti accompagnassi a casa, perché Michele non rispondeva al telefono e mi hai chiesto di salire.”
La Coca Cola mi va di traverso. Do un colpo di tosse per riprendere il controllo e gli sorrido per incoraggiarlo a continuare.
“Siamo saliti e mi hai detto che avevi voglia di scioglierti un po’.”
Mi sento svenire.
“Hai bussato alla porta della tua vicina chiedendole della Vodka e sei tornata con la bottiglia.
Non volevo che bevessi ancora. Ti ho abbracciata e ti ho messa a dormire. Ti sei sdraiata sul letto e Michele è arrivato subito dopo. Fine della storia.” conclude sorridendo, mentre abbassa lo sguardo.
Puntuale e conciso.
Ma all’appello manca giusto ‘il gran finale’ di cui parlava all’inizio: cosa mi nasconde?
“E gli orsetti?” mi affretto a chiedere prima che sia troppo tardi.
Lo vedo arrossire e capisco che ho visto giusto: cosa sta evitando di dirmi?
“Prima di andarmene, mi sono avvicinato, ti ho detto che avrei voluto rivederti e tu hai annaffiato gli orsacchiotti. Io sono stato colpito solo di striscio…”
Adesso muoio.
Non so cosa dire. E non so se è perché ho appena scoperto di avergli vomitato addosso, o perché mi ha detto che avrebbe voluto rivedermi e io me lo sono persa.
Devo fare qualcosa, dire qualcosa, tipo:
‘ma prima di dare di stomaco, ho detto che anch’io avrei voluto rivederti?’ Ma mentre cerco il coraggio di fare uscire dalla mia bocca la sola domanda che abbia senso, Davide si mette una mano in tasca e prende il telefono che sta vibrando.
“Devo rispondere, scusami un attimo”, mi dice mentre apre il suo Nokia.
“Sto arrivando. Dieci minuti e sono lì.”
Chiude il telefono e lo rimette in tasca.
“Eva devo andare, mi aspettano alla cena della squadra.”
Lo accompagno alla porta rassegnata, consapevole di non avere il tempo di aggiungere altro e cambiare le sorti della serata, afferro la maniglia e lui si avvicina guardandomi negli occhi.
“Posso chiamarti domani?”
Non so se fosse questa la frase che mi sono persa, ma anche questa mi piace.
“Volentieri.”
Si abbassa, mi dà un bacio sulla guancia ed esce di casa.
Rimango immobile per dieci secondi, guardando la porta, forse sto solo cercando un punto fisso per non svenire dall’emozione. Ma appena sento il ruggito della sua auto che si mette in moto, mi precipito sul terrazzo.
Lo vedo uscire dal parcheggio, lo immagino alla guida con i capelli al vento e le mie guance vanno a fuoco.
Dio come sarebbe bello chiamarlo e chiedergli di tornare qui, da me.
Ma riflettendoci, preferisco interrogare Michele su un paio di cose che non mi tornano.
E mentre recupero il telefono dalla borsa, mi accorgo del volantino che ho trovato stamattina nella casetta delle lettere.
Magnalonga: Dodici chilometri con dodici tappe enogastronomiche. Pancetta, patatine, mortadella, tortelloni, gramigna, tigelle con il lardo, zampone e fagioloni. Macedonia e gelato. Il tutto accompagnato da Pignoletto, Lambrusco, Trebbiano e Malvasia. Caffè e Ammazzacaffè.
Quello sprovveduto mi ha lasciato sola per tutta la sera. Avrò la mia vendetta.
Digito il suo nome sul telefono e lo chiamo.
“Quindi? Ci sono sviluppi?” mi chiede ansioso.
“Più di quanti immagini… potresti spiegarmi perché mi hai lasciata in discoteca con lui e non hai risposto alle mie telefonate? Non avevi detto di avermi abbandonato solo per dieci minuti?” dico in tono pungente.
“Scusa, ma ho una chiamata sotto, possiamo sentirci dopo?”
“No carino, ora mi starai a sentire… hai presente la Magnalonga?”
“Sì… quella cosa che, quando hai finito, se sei fortunato te la cavi con una settimana di dialisi?”
“Proprio lei. La facciamo insieme.”
“Sei pazza? Hai sempre odiato queste cose!”
“Ma tu le odi di più… e una punizione te la meriti.”
“Ho così tanto da farmi perdonare?”
“Se è per questo anche di più!”
SETTIMO EPISODIO
Illustrazione: Valeria Terranova